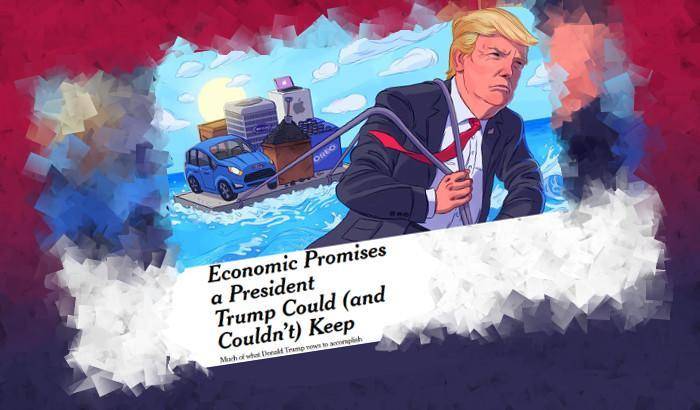I guai dell’Eurozona originano da
una grave anomalia: l’essere imperniata su un paese esportatore, che
drena valuta invece di crearla. Il ritorno della Mitteleuropa.
Il bluff delle ‘triple A’. Se la moneta comune salta, un’Italia senza
timoniere rischia la deriva.
di Marcello De Cecco e Fabrizio Maronta da Limes 4/13.
Per gentile concessione della
rivista Limes, Keynesblog pubblica il seguente articolo di M. De Cecco e F.
Maronta. Il sommario dell’interessantissimo numero, tutto dedicato
all’Euro e all’Europa, è disponibile qui.
1. La zona euro detiene invidiabile
primato storico: è l’unica area monetaria imperniata su un paese
creditore, la Germania. Si tratta di una condizione assolutamente
anomala: mai, prima d’ora, si era data una moneta a circolazione
plurinazionale costruita attorno a un paese strutturalmente esportatore,
perché la funzione del fulcro di un sistema monetario è creare
liquidità , non drenarla. Tale funzione viene normalmente assolta
mediante il commercio: importando beni e servizi altrui e stampando
moneta per pagare le importazioni, il paese economicamente egemone
alimenta la massa monetaria della sua zona d’influenza, fornendo così il
carburante degli scambi e degli investimenti. Ciò presuppone, però, un
deficit commerciale quasi permanente e una certa tolleranza, da parte
del paese in questione, per l’inflazione e le oscillazioni del tasso di
cambio.
Questa è stata la condotta
dell’Inghilterra, specialmente tra la prima e la seconda guerra
mondiale, quando Londra reinvestiva sistematicamente i proventi delle
colonie alimentando il commercio mondiale e tamponando i guasti
provocati dall’aggressivo mercantilismo statunitense, in una fase in cui
Washington era impegnata ad affermarsi sui mercati internazionali.
Questa è stata la posizione degli Stati Uniti a partire dal secondo
dopoguerra, una volta rilevato il testimone dal Regno Unito: prima con
il Piano Marshall, che schiuse l’enorme mercato nordamericano
all’esangue industria europea; poi, dopo l’abbandono unilaterale del
sistema di parità aurea – reso insostenibile proprio dalla crescita
degli scambi transatlantici – con la creazione di moneta.
Non è questo il caso della Germania:
paese che ad oggi mantiene una percentuale di esportazioni sul pil (50%)
superiore persino a quella della Cina, ma che in virtù della sua
statura economica si è sempre trovato al centro delle dinamiche europee
d’integrazione commerciale (prima) e monetaria (poi). Un ruolo,
tuttavia, svolto senza mai abdicare alla propria natura di Stato
esportatore. Questa anomalia è esplosa con la creazione dell’euro, che
ha determinato un paradossale rovesciamento dei ruoli: la Germania,
fulcro dell’area valutaria comune, non crea liquidità , ma la assorbe
costantemente, esportando beni e servizi altamente competitivi che
vengono pagati dagli importatori più o meno «periferici» dell’Eurozona
emettendo debito. Ovvero, sobbarcandosi quella funzione di zecca
monetaria che spetterebbe a Berlino.
Quest’ultima, in realtà , per qualche
tempo dopo la riunificazione fu costretta a stampare moneta, per
assorbire l’immane fardello economico e fiscale dell’Est. In quel
periodo (siamo a metà degli anni Novanta), i benefici dell’abbondanza di
marchi si fecero sentire in tutta Europa, ma la festa è durata poco.
Bundesbank, governo e parti sociali reagirono con un doloroso programma
di contenimento della spesa pubblica; con una ferrea politica di
moderazione salariale, negoziata con i sindacati; e con una profonda
razionalizzazione del mercato del lavoro, che ha infranto il tabù
post-bellico del posto fisso e ha creato un’ampia area di lavoro
flessibile, essenziale alla competitività del made in Germany.
La risultante precarietà lavorativa è stata tamponata da uno Stato
sociale la cui leggendaria generosità è uscita ridimensionata dalla cura
dimagrante dell’èra Schröder. Ma che resta pur sempre un welfare vero,
dove lo Stato fornisce servizi efficienti a valere sulla fiscalitÃ
generale e in regime di bassa evasione. Una realtà assai lontana da
quella italiana, dove l’evasione fiscale vale circa il 20% del pil, le
pensioni finanziano i consumi e le reti della solidarietà (soprattutto)
cattolica suppliscono alla mancanza di servizi, in un arcaico baratto
tra diritti e carità .
Da parte sua, il mondo produttivo
tedesco – specialmente la grande industria – ha puntato con decisione su
ricerca e innovazione, onde mantenere alto il valore aggiunto dei suoi
prodotti e contribuire all’aumento della competitività . Questa, a sua
volta, ha consentito all’industria tedesca – metodicamente sostenuta da
governi e sistema bancario – di insediarsi stabilmente nei mercati
emergenti (soprattutto in Cina), di cui ha agganciato il ciclo economico
espansivo. Certamente, una grossa mano è venuta dall’Europa. Specie da
Francia e Inghilterra, che all’indomani del 1989 accettarono di trattare
la riunificazione tedesca alla stregua di un allargamento comunitario e
la Germania Est come nuovo Stato membro, per consentirle di
aggiudicarsi ingenti aiuti economici. Così suggellando il patto storico
che voleva la riunificazione tedesca cofinanziata dai partner europei e
la Germania (ri)unita ancorata saldamente all’Europa per tramite
dell’euro.
Ma forse quel patto chiedeva troppo ai
suoi contraenti: ben presto i tedeschi hanno realizzato che calarsi nel
ruolo di «America d’Europa», accettando un persistente deficit fiscale e
commerciale per finanziare l’export britannico, francese, iberico e
italiano, avrebbe distrutto l’armonioso sistema di relazioni sociali e
industriali che costituisce la cifra del capitalismo renano, sul quale
la Germania ha ricostruito se stessa dopo la catastrofe bellica. Questo
sistema, intrinsecamente avverso all’inflazione, presuppone degli
elementi strutturalmente incompatibili con il ruolo di creatore
internazionale di valuta: un’attenta regia della Banca centrale
sull’economia, una moderazione salariale da parte dei sindacati, un
occhiuto controllo della spesa pubblica, il mantenimento di un’alta
produttività da parte delle aziende.
Più che il famigerato ricordo di Weimar –
costantemente evocato dagli osservatori stranieri, ma di fatto estraneo
alla maggior parte dei tedeschi contemporanei, se non altro per ragioni
anagrafiche – è dunque l’insostenibilità economica dell’inflazione a
rendere cittadini e leader tedeschi inflessibili di fronte a ogni
ipotesi di lassismo monetario. Malgrado non si debba mancare occasione
di ricordare alla Germania quanto l’Europa abbia contribuito, a suon di
deficit commerciali, a finanziare la sua riunificazione, sarebbe anche
bene che qualcuno, nei cosiddetti paesi debitori, evidenziasse con
maggiore enfasi l’entità dei sacrifici cui i tedeschi si sono sottoposti
per riedificare l’Est. In ultima analisi, la Germania è riuscita a
tenere in riga i conti pubblici e a mantenere competitiva la propria
industria pur sborsando l’equivalente di 200 miliardi di marchi all’anno
per vent’anni a favore dei Länder orientali. Dieci volte più di quanto
il nostro Nord abbia dato al Mezzogiorno in oltre un secolo.
2. Oggi è giunto il momento di chiederci
onestamente se Berlino sia in grado di svolgere la funzione di fulcro
del sistema monetario europeo. Ovvero, se abbia validi incentivi a
ricoprire tale ruolo. La sua storia suggerisce il contrario: sin
dall’unità nazionale (1870), la Germania ha registrato un costante
surplus nel settore dei beni d’investimento, non a caso coincidente con
l’industria bellica. Quando il paese non era impegnato in guerre
d’espansione finalizzate a ritagliarsi l’agognato Lebensraum,
l’efficiente industria pesante si riconvertiva alla produzione civile,
che alimentava il mercato nazionale e poi – una volta completata
l’industrializzazione e la messa in piedi di una poderosa rete
infrastrutturale interna – le esportazioni.
Questo meccanismo ha preso ulteriore
slancio nel secondo dopoguerra, quando gli Stati Uniti, appresa la
lezione keynesiana di Versailles e di fronte alla minaccia sovietica,
hanno optato per agevolare in ogni modo l’export tedesco, come mezzo di
ricostruzione economica alternativo all’ormai impraticabile (per Bonn)
politica degli armamenti. Mai scelta fu più felice: sostituiti i marchi
ai Panzer, come si suol dire, la Germania (Ovest) ha
interiorizzato l’uso dell’export come valida alternativa alla politica
di potenza militare. Il risultato è stato una politica di potenza
implicita, che nominalmente non infrangeva il tabù della sottomissione
tedesca all’Europa e agli Stati Uniti, ma che di fatto ha consentito al
paese di risorgere economicamente, politicamente e socialmente. Il
prezzo economico pagato dalla Germania per l’acquiescenza euroatlantica
al suo mercantilismo è stato il ruolo di ufficiale pagatore dell’Europa:
prima dell’euro, in qualità di principale (ancorché non unico)
contributore netto al bilancio comunitario; dal 2002 in poi, anche
mediante la condivisione del suo merito di credito con le economie meno
disciplinate e competitive di Eurolandia.
Ma questa camicia di forza valutaria non è valsa a mutare i connotati di fondo del sistema economico tedesco e della forma mentis
ad esso sottesa. La Germania era e resta un paese naturalmente votato
all’export: basta leggere lo statuto della Deutsche Bank, in cui è
scritto nero su bianco che la banca nasce per favorire le esportazioni
tedesche. In quale altro paese il principale gruppo bancario privato ha
come mission statuita il sostegno all’industria nazionale nella
conquista dei mercati esteri? Dunque la Germania si trova in una
posizione per certi versi ambigua: essa è il fulcro di un’area valutaria
che continua a ospitare il grosso dei suoi interessi commerciali; al
contempo, però, è fortemente insediata in mercati esterni che, stante la
severità della crisi europea, risultano sempre più importanti.
Non che i destini dell’Europa
mediterranea siano indifferenti alla logica economica di Berlino. I
reprimendi Pigs sono stati tradizionalmente delle spugne dell’export
tedesco. L’Italia, in particolare, non è solo un mercato di sbocco, ma
anche un importante acquirente di beni intermedi presso il settore
chimico, meccanico e farmaceutico tedesco. Se dunque il crollo del
nostro potere d’acquisto danneggia le esportazioni tedesche, altrettanto
fa l’incipiente deindustrializzazione che sta investendo il Belpaese.
Senza contare che il settore bancario di Berlino – specie le banche
regionali – è in condizioni preoccupanti, non da ultimo per l’ingente
esposizione verso le economie debitrici. Tutto questo spiega perché la
Germania eviti di spingere a fondo sul pedale della sua competitività in
Europa, sfruttando l’assenza di barriere valutarie e doganali nella
zona euro per fare dumping commerciale alle altre economie
manifatturiere (come l’Italia), che verrebbero spinte fuori mercato con
conseguente implosione dell’Eurozona.
Si spiega così anche l’appoggio della
Merkel alle audaci operazioni d’acquisto di titoli (soprattutto)
italiani e spagnoli sul mercato secondario da parte della Bce di Mario
Draghi, che per formazione culturale è più vicino a Ben Bernanke che a
Jens Weidmann. Resta però che Draghi non può supplire all’assenza di un
coordinamento politico europeo, men che meno alla drammatica vacatio
di Roma. Ma soprattutto, non può mutare due dati di fondo:
l’impossibilità di un duraturo riequilibrio della bilancia commerciale
intraeuropea, stante il carattere intrinsecamente mercantilistico
dell’economia tedesca; e la parallela incompatibilità del lassismo
economico mediterraneo (che pure ha consentito a Italia, Spagna, Grecia e
Portogallo di acquistare a debito le merci tedesche) con un capitalismo
renano che postula la disciplina fiscale come elemento strutturale
della propria competitività .
3. A questa relazione problematica e
conflittuale si contrappone la cogenza dei legami storici che ancorano
la Germania alla sua tradizionale area d’influenza economico-valutaria.
All’ombra dell’euro si è andata ricostituendo quella Mitteleuropa che
dal 1870 a oggi, con la parentesi della cortina di ferro, ha
rappresentato il cuore produttivo e finanziario del continente. Nonché
la spiegazione dell’apparente mistero per cui un paese relativamente
piccolo come la Germania, arrivato tardi all’unità nazionale e uscito
sconfitto da due guerre mondiali, sia assurto a potenza esportatrice
globale, tenendo testa a giganti economici e demografici quali il
Giappone, la Cina e gli Stati Uniti. La risposta sta, appunto, nell’area
d’integrazione economico-produttiva tedesca, già zona d’influenza del
marco: la quale, oltre alla Germania, include Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Austria, Liechtenstein, Polonia, Slovenia,
Croazia, Svizzera, Repubbliche baltiche, Olanda e Lussemburgo, più la
Francia carolingia e parte dell’Italia settentrionale. Sommati, questi
territori assommano a quasi 165 milioni di persone e al grosso del pil
europeo.
Oggi, di fronte a una crisi globale che
ha portato al pettine i nodi di un’unione monetaria mal concepita, si va
profilando un dilemma epocale, dalla cui risposta dipende il futuro
stesso dell’euro. Quest’ultimo ha costituito l’apice di un
pluridecennale iter di «normalizzazione» della Germania, dopo i disastri
delle due guerre. Tale processo, vigilato dagli Stati Uniti e seguito
con apprensione da una Francia e da un’Inghilterra scottate dal
militarismo tedesco, è passato per la divisione del paese e il suo
imbrigliamento nelle sfere d’influenza statunitense e sovietica. Nel
caso della Germania occidentale, ciò ha comportato l’integrazione nella
Nato e in una costruzione europea il cui atto di nascita prevedeva la
messa in comune di carbone e acciaio. Cioè della base su cui Berlino
aveva costruito la sua potenza militare. Caduto il Muro, ad essere
precipitosamente diluite nel condominio comunitario furono la Banca
centrale e la moneta tedesche, ulteriore antidoto alla presunta minaccia
posta da una Germania riunificata.
Ora l’espiazione è conclusa: pezzi
importanti dell’establishment economico e politico tedesco considerano
il paese pienamente riabilitato e pertanto faticano a giustificare a se
stessi, oltre che alla propria opinione pubblica, l’adesione acritica a
paradigmi in parte o in tutto contrari alla traiettoria economica e
geopolitica del paese. Ovvero al suo interesse nazionale, almeno nella
percezione che di questo hanno i ceti politici e produttivi in grado di
orientare le scelte strategiche di Berlino. Alcuni, come il
neocostituito partito Alternative für Deutschland (Alternativa per la
Germania), lo dicono apertamente; altri sono più obliqui. In ogni caso,
l’euro – e di riflesso la concezione federalista dell’Europa, di cui la
moneta unica è somma espressione – sembra aver in gran parte esaurito la
sua funzione storica agli occhi di un paese che si sente «redento». Ma
venuto meno il vincolo storico e strategico, di fronte alla peggior
crisi economica dell’ultimo secolo e a un’America che non ha più nel
Vecchio Continente il suo ambito d’interesse prioritario, la mera
esistenza della moneta unica è, di per sé, un vincolo sufficiente alla
sua sopravvivenza? Nell’ottica della Germania – paese dalla cui volontÃ
politica dipende, in ultima istanza, l’esistenza della moneta unica – i
vantaggi dell’euro continuano a superarne i costi?
Difficilmente una risposta negativa può
essere esclusa a priori. Pertanto, la spaccatura della moneta unica
cessa di essere un’ipotesi di scuola, sebbene resti ufficialmente un
tabù. È improbabile che l’iniziativa di un’uscita unilaterale venga
dall’Italia: paese teoricamente in grado di far saltare il banco o di
utilizzare tale minaccia per negoziare un’attenuazione dell’austerità ,
ma di fatto paralizzato dal terrore delle conseguenze di una simile
scelta e attualmente privo di una guida politica capace di teorizzare e
attuare qualsivoglia disegno strategico, più o meno audace. Date le
dimensioni della nostra economia e dei nostri problemi, non servirebbe
peraltro un atto plateale; basterebbe omettere di attuare le misure di
austerità concordate in sede europea. Ciò in parte sta già accadendo, ma
più per inerzia burocratica che per volontà politica, dato che svariate
misure di austerità varate dal governo Monti mancano ad oggi dei
necessari decreti attuativi. Finora l’austerità è consistita
nell’ennesimo aumento delle tasse a danno di chi le tasse le paga;
mancano le riforme strutturali della spesa pubblica, le uniche in grado
di spezzare la spirale del debito e di consentire la riduzione di una
pressione fiscale ormai insostenibile.
Più probabile che, se divorzio
dev’essere, a prendere apertamente l’iniziativa sia il coniuge più
volitivo e munito di dote. La Germania, ancorché restia a provocare un
terremoto valutario che nell’immediato affonderebbe alcuni dei suoi
principali mercati, potrebbe giungere alla conclusione che l’euro è
un’opzione non più praticabile. Specialmente se il perdurare della crisi
dovesse determinare un tracollo dell’export verso l’Europa e il mercato
cinese non dovesse riuscire a compensare l’ammanco. Per ragioni uguali e
contrarie, la Francia – che a differenza dell’Italia conserva una
chiara concezione del proprio posto nel mondo, ma che a differenza della
Germania ha una situazione economico-finanziaria assai precaria –
potrebbe giungere alla medesima conclusione. Ma ciò presupporrebbe un
drastico peggioramento del quadro economico e occupazionale francese,
essendo la permanenza di Parigi nell’empireo dei probi strettamente
connessa al suo legame economico e geopolitico con la Germania.
Il crack dell’euro schiuderebbe scenari
da incubo per un paese politicamente acefalo qual è attualmente
l’Italia, che perso il pur problematico ancoraggio europeo sarebbe
costretto a navigare in mare aperto senza nessuno al timone. E insieme
svelerebbe impietosamente il bluff delle «triple A», per il quale
l’Europa risulta artificiosamente divisa in un paradiso di creditori –
cui va il plauso delle agenzie di rating – e un purgatorio di debitori –
con scorci d’inferno, come nel caso greco e cipriota. Ridotto alla sua
essenza, il vagheggiato Neuro (euro del Nord) altro non sarebbe che il
redivivo marco tedesco. E l’esclusivo club dei creditori si scoprirebbe
per ciò che realmente è: una società ad azionista unico – la Germania –
attorno alla quale gravitano svariati clientes dipendenti in
tutto e per tutto dalla performance dell’export germanico. Il quale
trarrebbe notevole pregiudizio dal collasso del mercato europeo.
Nel corso della loro turbolenta e
plurisecolare storia, gli europei hanno appreso a loro spese che nessun
paese è un’isola e che questa regola non ammette eccezioni. Nemmeno per
Berlino.
Tratto da: http://keynesblog.com/2013/05/20/berlino-roma-e-i-dolori-del-giovane-euro/#more-4191.
Fonte originale: http://temi.repubblica.it/limes/litalia-di-nessuno/46032.
[GotoHome_Vai alla Prima Pagina]