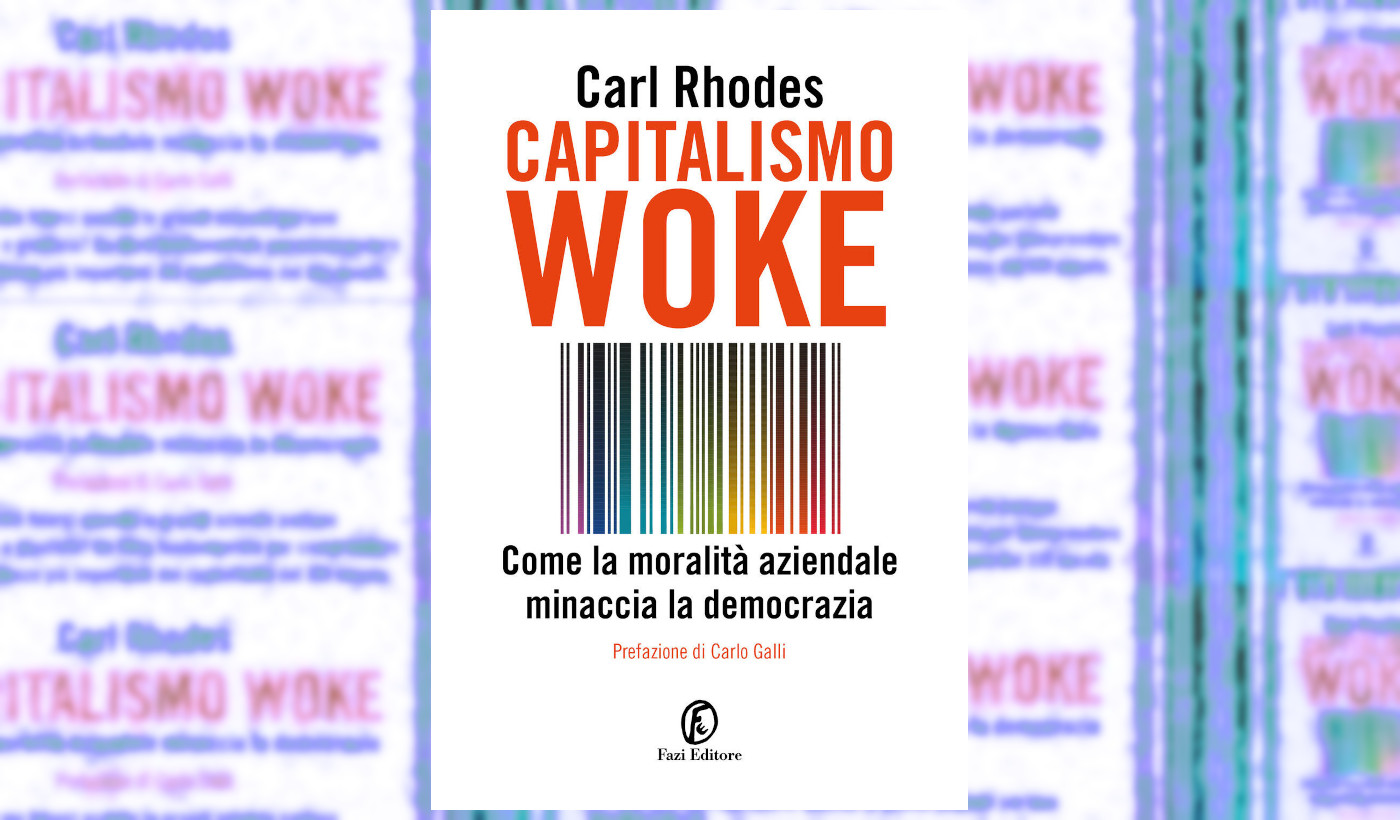Fantasticare e pensare la vita secondo delle trame narrative scandite da ascese, cadute e resurrezioni. Rimpiangere quello che non siamo stati e ciò che non abbiamo fatto, dal massimo delle scelte professionali e sentimentali al minimo delle ordinazioni al ristorante. Immaginarsi altri mondi e farsi i fatti altrui. Essere riconosciuti e riconoscere. Tutto questo fa parte della nostra vita normale, e quando Nietzsche disse di essere «tutti i nomi della storia» (e che la coscienza è «la voce del gregge che è in noi») mise in luce enfaticamente questo stato di cose.
Se infatti guardiamo ai primi ricordi della nostra vita noteremo che, insieme a sensazioni (l’odore di certe medicine, famigliari, compagni di scuola) si mescolano inestricabilmente con ricordi di letture, cose viste, in certi casi persino immaginazioni o incubi. Il nostro essere noi stessi — ecco la tesi fondamentale dell’ultimo libro di Remo Bodei, Immaginare altre vite — è intessuto dalla narrazione delle vite degli altri. Non nel senso di spiare o inquisire, ma proprio nel senso, banale, che quello che noi siamo è il risultato di modelli che ci vengono dall’esterno, ed è questo il motivo per cui nella formazione degli esseri umani l’educazione — che, in quella che si chiama “formazione umanistica†consiste essenzialmente nella narrazione di vite vere o immaginarie — e l’imitazione di modelli e comportamenti rivestono un ruolo così importante.
L’uomo è un essere “intrinsecamente narrativoâ€, come suggerisce il titolo dell’autobiografia degli anni giovanili di GarcÃa Márquez: Vivere per raccontarla.
Una parte importante della nostra vita come esseri riflessivi si impegna, in modo più o meno consapevole, a rendere accettabile la trama di un racconto, che da giovani è proiettato verso il futuro (e dunque è in buona parte intessuto di proiezioni e di immaginazioni di vite altrui), mentre da vecchi è fatta di rattoppi, cancellature, riscritture. Ecco che cosa ha spinto un uomo a dipingere degli animali sulle pareti di una caverna e, a maggior ragione, altri a guardare come in qualche modo significativi quei raddoppiamenti della realtà . Una narratività che si moltiplica con la crescita di registrazioni, immagini, racconti, in cui consiste lo sviluppo della cultura. E che adesso raggiunge il massimo evolutivo, in quel complicato intreccio di realtà e immaginazione che viene offerto dal mondo del web.
Se le cose stanno in questi termini — questo il suggerimento di Bodei — bisognerebbe correggere una immagine ingenua con cui rappresentiamo il nostro comportamento, come se fosse animato da un istinto immune e originario. È vero l’inverso: i bisogni e le aspirazioni vengono dall’esterno, appunto dai modelli che abbiamo avuto o dalle regole con cui ci siamo confrontati e che inizialmente abbiamo seguito in forma irriflessa. Rari sono i casi in cui diventiamo consapevoli di questo processo. E ancora più rari sono i casi in cui quello che siamo ci basta.
Così, la nostra coscienza si presenta come un [i]patchwork[/i] in cui giocano un ruolo essenziale i nostri modelli, consapevoli e inconsapevoli, per cui quello che siamo è costituito in maniera rilevante da ciò che vorremmo essere. Non si tratta di un paradosso, ma della condizione normale della coscienza. A questo punto, la buona domanda non è tanto quanto dobbiamo agli altri, alla fantasia e alla narrazione, ma come facciamo a evitare la sensazione pirandelliana di essere uno, nessuno e centomila. E qui la risposta, che Bodei trae dall’idealismo tedesco e dalle sue riletture contemporanee ma che forse può essere situata ancora più indietro, in quello che i mistici medioevali chiamavano fundus animae, è l’opacità , la resistenza alla comprensione e alla trasformazione.
Abituati a immaginare altre vite e a credere di sapere benissimo come si sentiva Cesare alle Idi di marzo, scopriamo che per quello che ci riguarda non siamo affatto un libro aperto. E che la metafora che ci si attaglia di più è casomai quella di una brevissima novella di Kafka: «Siamo… come tronchi d’albero sulla neve. Questi giacciono lì solo apparentemente e con una piccola spinta dovrebbe essere possibile spostarli. Invece no, non si può, perché sono attaccati saldamente al terreno».
(28 gennaio 2014) [url”Torna alla Home page”]http://megachip.globalist.it[/url]