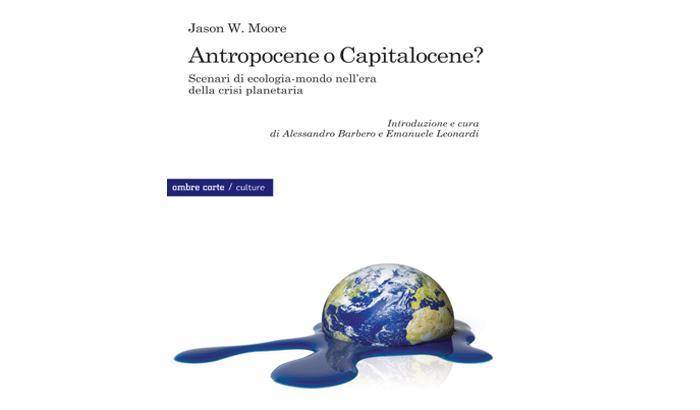di Sara Baranzoni e Paolo Vignola
Antropocene, che è costui? Con una formula decisamente sintetica, si potrebbe rispondere l’era geologica in cui l’attività umana è diventata il principale fattore di trasformazione della biosfera. A tale formula stringata, però, corrisponde uno dei dibattiti più partecipati, da parte di filosofi, antropologi e scienziati sociali, dai tempi della “condizione postmoderna” – verrebbe da dire, altra era… Stando a Jason W. Moore, autore del libro Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia mondo nell’era della crisi planetaria, a scapito dell’ampiezza del dibattito, il concetto “Antropocene” cela in realtà almeno un paio di errori strategici. Il primo sarebbe relativo all’origine della datazione, che i coniatori del termine, Stoermer e Crutzen, così come l’interpretazione prevalente, attribuiscono alla prima rivoluzione industriale, mentre il secondo si situerebbe nella confusione tra cause (economico-politiche) ed effetti (ambientali). Nel concetto di Antropocene si celerebbe inoltre un malinteso filosofico rispetto al rapporto natura/società, nonché una impostura politica, quella di attribuire all’umanità in generale e al suo consumo delle risorse la causa dell’imminente catastrofe ambientale.
Questi sono del resto, per Moore, i fattori che, muovendo dalla nozione scientifica di Antropocene (ancora comunque da validare) hanno prodotto «l’Antropocene alla moda», ossia «l’ultimo di una lunga serie di concetti ambientali la cui funzione è quella di negare la disuguaglianza e la violenza multi-specie del capitalismo e di suggerire che dei problemi creati dal capitale sono in realtà responsabili tutti gli umani. La politica dell’Antropocene [è] un’anti-politica» (31). La risposta di Moore è allora quella di politicizzare alla radice il tema del cambiamento climatico e dell’azione geologica dell’uomo: «Il cambiamento climatico non è il risultato dell’azione umana in astratto – l’Anthropos – bensì la conseguenza più evidente di secoli di dominio del capitale. Il cambiamento climatico è capitalogenico» (29).
Moore è convinto che la teoria dell’Antropocene oscuri più di quanto illumini, nel senso che «offusca le reali relazioni esistenti tra uomini e donne che fanno la storia con il resto della natura: le relazioni di potere, (ri)produzione e ricchezza nella rete della vita» (41). In particolare, quello che più manca al concetto di Antropocene è una «prospettiva storico-relazionale» che spieghi lo sviluppo, a partire dal lungo XVI secolo, «dei rapporti che hanno consentito la nascita dell’era dell’umanità come agente geologico qualche tempo dopo il 1800» (126). Per l’autore si tratta delle relazioni di potere, natura e ricchezza sviluppatesi a partire dalla scoperta delle Americhe e senza le quali sarebbero state impossibili le rivoluzioni industriali, con tutto ciò che ne conseguirà in termini “antropocenici”. Risulta in tal senso utile riportare una delle considerazioni più espressive e politicamente cristalline del libro, che giustificano l’impiego del termine Capitalocene:
[…] individuare le origini del mondo moderno nella macchina a vapore e nelle miniere di carbone significa dare la priorità alla dismissione delle stesse macchine e miniere (e delle loro incarnazioni del XXI secolo). Collocare le origini del mondo moderno nell’ascesa della civiltà capitalista a partire dal 1450, con le sue audaci strategie di conquista globale, mercificazione infinita e razionalizzazione implacabile, significa dare precedenza ai rapporti di potere, sapere e capitale che hanno prodotto – e ora stanno distruggendo – il mondo moderno come l’abbiamo conosciuto. Chiudi una miniera di carbone e potrai attenuare il riscaldamento globale per un giorno; interrompi i rapporti che costituiscono la miniera di carbone e portai fermarlo una volta per tutte (42).
Capitalocene significa allora «l’Età del Capitale-nella-natura» (137), il che a sua volta vuole dire che «la creazione di valore non si dà sulla natura, ma attraverso di essa – cioè dentro i rapporti socio-naturali che emergono dall’articolazione variabile di capitale, potere e ambiente» (19), come Emanuele Leonardi e Alessandro Barbero scrivono nella loro introduzione al libro di Moore. In tal senso, con le parole dell’autore, «il Capitalocene mostra il deterioramento della natura come espressione specifica dell’organizzazione capitalistica del lavoro» e, assieme, il “lavoro” come «un processo geo-ecologico molteplice e multi-specista» (35).
L’Antropocene come sintomo…
Il libro è composto da due lunghi articoli di Moore, pubblicati in inglese nel 2014, la prefazione dell’autore all’edizione italiana e una utile introduzione tematica, a firma dei curatori, che ripercorre in modo agile ma estremamente preciso lo sviluppo del dibattito sull’Antropocene e le possibilità di innesco di questo concetto nell’ambito della critica al capitalismo del XXI secolo. Più in particolare, l’intenzione del saggio introduttivo è trattare l’Antropocene come «sintomo del sociale contemporaneo» (7), il quale non nomina solo una nuova epoca geologica, ma anche «un inedito regime di governance dell’ambiente globale» (10). Ed è per tale ragione che il concetto stesso di Antropocene deve essere politicizzato, o addirittura deve essere inteso come una invenzione politica. Emblematica, e per certi versi “estrema”, è allora la seguente considerazione di Andrew Ross, riportata nell’introduzione:
[è] molto probabile che l’impatto delle politiche di austerity creerà problemi all’asse lavoratori-ambientalisti (del resto, tali politiche sono finalizzate a ciò), ma è anche indubbio, ormai, il grande potenziale di una sincronizzazione dei movimenti per la giustizia sociale, economica e ambientale. Tale potenziale ha ricevuto una notevole spinta propulsiva dalla crisi climatica. A dire il vero, se la crisi climatica non fosse esistita sarebbe forse stato necessario inventarla di modo che tale sincronizzazione potesse infine prendere corpo (14).
Se è sicuramente su questo piano prescrittivo che il lavoro di ricostruzione storica e sociologica di Moore risulta letteralmente fondamentale, l’introduzione di Leonardi e Barbero si spinge più in là della visione offerta dal sociologo americano, utilizzando come leva proprio l’aspetto strategicamente principale del concetto “Capitalocene”, ossia il suo carattere relazionale. In altre parole, se il Capitalocene è un concetto che pone le relazioni del capitale nella rete della vita come principio inaggirabile dell’analisi, i curatori provano a (far) ragionare sull’Antropocene proprio stabilendo relazioni: con gli algoritmi nel senso più generale (dall’agrigeometria al platform capitalism), con la critica dell’economia politica, con il General Intellect e il comune, da un lato, e con i dispositivi proletarizzanti del capitalismo cognitivo, dall’altro lato. L’effetto è innanzitutto un arricchimento della prospettiva di Moore, la cui analisi, focalizzata nella genealogia dell’economia/ecologia-mondo, non contempla appunto né l’impatto cognitivo, affettivo ed epistemico, né la dimensione algoritmica del capitalismo contemporaneo. Ed è da tale arricchimento che l’introduzione svela una intenzione ambiziosa e quanto mai necessaria, ossia pensare un nuovo piano di composizione politica delle lotte e delle soggettività critiche, seguendo le varie declinazioni del pensiero ecologista e provando a innescare un dialogo virtuale con alcune tesi centrali dell’operaismo. Il fine è allora quello «di una re-invenzione radicale del lavoro, di una ri-localizzazione della produzione e di una ri-appropriazione autonoma della tecnologia» (25), in vista di un affinamento ecologico del comune e con il contributo, diretto e indiretto, di autori attenti al tema “antropocenico” come Matteo Pasquinelli, Mckenzie Wark, Andrew Ross, Dipesh Chakrabarty, Naomy Klein, Bernard Stiegler, Donna Haraway, Miguel Benasayag e Gérard Schmit, o pionieri dell’ecologia politica come André Gorz.
… e il capitalismo come metabolismo
La critica di Moore muove dal presupposto che l’idea di una natura esterna ai processi di valorizzazione esprima un duplice riduzionismo, per cui da un lato, ossia all’inizio del processo economico, l’ambiente è concepito come risorsa infinita e gratuita, mentre dall’altro lato, ossia alla fine di tale processo, lo stesso ambiente funzionerebbe come una specie di immensa – infinita appunto – discarica per rifiuti a costo zero. Tale riduzionismo diffuso, a cui non sfuggirebbe gran parte del pensiero ecologico materialista, è inteso dall’autore come un vizio dualistico cartesiano che, a partire dalla separazione antropocentrica uomo/ambiente, spinge a pensare l’industrializzazione come azione sullanatura, intesa come una risorsa esterna al capitalismo: «L’ecologia di sinistra tende ancora a pensare al capitalismo e alla natura invece che al capitalismo-nella-natura» (52). Il problema del pensiero ecologico risiederebbe cioè nell’analizzare il «metabolismo» socio-ambientale dell’industrializzazione, della globalizzazione e più in generale del capitalismo, quando dovrebbero essere questi stessi fenomeni a essere studiati come metabolismi, ossia come modalità storiche di organizzare la natura: «la legge del valore è un modo di organizzare la natura» (102). In tal senso, il concetto di ecologia-mondo, proposto da Moore e fondato su di un approccio relazionale, indica la natura come matrice e non più o non solo come risorsa, nonché l’interdipendenza tra dinamiche sociali ed elementi naturali su cui si basano le trasformazioni del modo di produzione capitalistico nel corso della storia. Moore rivendica perciò una prospettiva «post-cartesiana che concepisca il valore come un metodo di organizzazione della natura. In questo modo, la legge di valore è co-prodotta nella rete della vita» (71). Tale legge del valore deve cioè essere intesa come la riorganizzazione progettuale e processuale delle «nature storiche del capitalismo», riorganizzazione che, negli ultimi cinque secoli, ha perpetuato un modello dicotomico per cui una parte della natura è stata interiorizzata come forza-lavoro umana, divenendo “sociale”, mentre l’altra è rimasta “natura”, ossia una sorta di dono che il capitale riceve per sussumerlo. Qui incontriamo la doppia dimensione del capitalismo, come progetto e come processo: «Il capitalismo, come progetto, emerge attraverso pratiche-mondo che creano la natura come un oggetto esterno da mappare, quantificare e regolare, affinché possa servire l’insaziabile domanda del capitale di natura a buon mercato. Allo stesso tempo, come processo, il capitalismo emerge e si sviluppa attraverso la rete della vita; la natura è ad un tempo interna ed esterna» (54).
Il capitalismo come progetto corrisponde dunque a ciò che la legge del valore intenderebbe fare, ossia delineare un mondo a misura e in funzione della intercambiabilità del valore, e per fare ciò deve postulare, cartesianamente, la natura come ambiente esterno. Prendiamo l’esempio paradigmatico del carbone, che in definitiva simboleggerebbe l’Antropocene, o almeno appare come la sua metonimia. Moore spiega come siano stati i rapporti sociali sviluppatisi a partire dal XVI secolo a trasformare il carbone dal suo statuto di roccia a quello di combustibile fossile, così come le conoscenze biologiche, fisiche, geologiche, concorrono a co-produrre l’idea stessa di combustibile. «Il pregiudizio del materialismo green ci dice che “il carbone cambiò il mondo”. Ma non è forse più plausibile la formulazione inversa? Nuovi rapporti di merce trasformarono il carbone. (Attivando nel frattempo il potere epocale del carbone)» (126). Se il vertiginoso sviluppo delle attività legate al carbone trasformò le condizioni della civiltà capitalista, secondo Moore è impossibile considerare queste ultime slegate dalle relazioni di valore che si erano sviluppate durante la prima modernità. Se risiede qui la grande miopia del concetto di Antropocene, è importante sottolineare che Moore non intende rinunciare al punto di vista geologico: «Specifiche formazioni geologiche, in circostanze storiche precise, possono diventare oggetto dell’attività umana e soggetto del cambiamento storico» (58). La geologia, semmai, deve diventare critica dell’economia politica.
Capitalismo-nella-natura: sapere, lavoro, frontiere
Moore pone un argomento antropologicamente decisivo per comprendere la cogenza delle sue tesi sul Capitalocene come esito di una economia/ecologia-mondo capitalista. Il colonialismo della prima modernità è innanzitutto frutto di un modo inedito di osservare e ordinare la realtà: «Si può conquistare solo se si può vedere. Da qui le prime forme di una natura esterna, spazio e tempo astratti, permisero agli imperi e ai capitalisti di costruire le reti globali di sfruttamento appropriazione, di calcolo e di credito, di proprietà e di profitto, su una scala senza precedenti» (69).
Tempo lineare, spazio piatto e omogeneo, natura esterna alle relazioni sociali: ecco gli ingredienti per colonizzare il mondo “scientificamente”, ossia tanto nel senso di una razionalizzazione e di un ordinamento della realtà attraverso gli strumenti della scienza e della tecnica, quanto nel senso della ricostruzione epistemica del mondo in un’unica visione possibile, attraverso l’epistemicidio di qualsiasi altra forma di sapere potenzialmente resistente al processo di colonizzazione d’oltreoceano. È quello che Donna Haraway, citata da Moore, descrive come «il “trucco di Dio”: trattare la specifica visione del mondo capitalista come naturale, pretendendo di specchiare il mondo in ciò che stava cercando di ri-costruire» (113).
Questo è il fine del capitalismo come progetto, un progetto di separazione tra esterno (natura) e interno (sociale), innervato da un riduzionismo quantitativo radicale, che risponde perfettamente alla formula baconiana “sapere è potere”: «La mappatura dello spazio fu la condizione costitutiva della conquista globale, non una sua semplice rappresentazione» (113-114). È così che, seguendo Moore, è andato sviluppandosi il rapporto tra natura sociale astratta e lavoro sociale astratto: «la natura sociale astratta rimanda alla relazione del capitale con il lavoro non retribuito attraverso cui le pratiche spazio-temporali identificano e facilitano l’appropriazione di lavoro non retribuito necessario all’accumulazione. Queste appropriazioni fanno qualcosa di più che fornire semplicemente le materie prime necessarie; esse co-determinano il tempo di lavoro “socialmente” necessario. In questo senso, la natura sociale astratta può essere intesa come direttamente costitutiva dei rapporti di valore nella creazione delle condizioni per la generalizzazione della produzione di merci e dello scambio» (104).
Per concludere questa schematica presentazione dell’opera, il Capitalocene come strumento per ripensare al tempo stesso l’ecologia politica e il capitalismo è un concetto relazionale che indica il formarsi di una trinità capace di reticolare l’intero globo: lavoro sociale astratto, natura sociale astratta e accumulazione originaria. «Questa è la relazione nevralgica della prassi-mondo capitalistica» (83), finalizzata a «produrre natura a buon mercato», ossia ottenere lavoro, cibo, energia e materie prime al costo più basso possibile e rispondere in tal modo allo sfruttamento entropico della forza-lavoro all’interno del sistema di mercato. È chiaro che tutto ciò è stato possibile grazie al dispositivo geopolitico delle frontiere, tema che del resto lega a doppio nodo gli esordi della colonizzazione delle Americhe al nostro presente:
Le frontiere erano la strada decisiva per far pagare agli altri – al di fuori del circuito del capitale ma alla portata del potere capitalistico – il conto per l’a sua infinita accumulazione. Il grande segreto e il grande traguardo del modo di produzione capitalistico è stato di non pagare i sui conti: ottenere qualcosa per nulla – o se non proprio per nulla, per il meno possibile […] L’accumulazione infinita di capitale e l’appropriazione senza fine della terra sono le due facce della stessa medaglia. L’una è impensabile senza l’altra […] Il saccheggio delle zone di frontiera e i progressi nella produttività del lavoro delle metropoli formano un tutto organico (131-132).
In ultimo, di fronte al dilemma terminologico “Antropocene-Capitalocene”, ci pare che Barbero e Leonardi abbiano trovato la loro postura filosofico-politica sulle orme del libro Molecular Red di McKenzie Wark, in cui il concetto e il termine stesso “Antropocene”, invece di essere messi radicalmente in questione, vengono pensati come una risorsa strategica per le lotte sociali, presenti e future. Come evidenziato da Leonardi e Barbero, in quest’ottica l’Antropocene è innanzitutto «un sintomo sociale da riconoscere per poterne re-indirizzare le potenzialità». Perciò, con le parole di McKenzie Wark, più che «interrogare l’Antropocene […] conviene prenderlo per ciò che è: un argutissimo trucco; esso introduce il punto di vista del lavoro – nel senso più ampio possibile – nella geologia”» (20-21).
Tale considerazione, sviluppata al di là degli elementi messi in campo da Moore, permette ai curatori del libro non solo di agganciare la critica del capitalismo cognitivo all’Antropocene, ma anche di innescare un processo teorico-politico interessante, per il cui sviluppo è necessaria una nuova cartografia delle lotte e degli autori impegnati a comprendere gli aspetti psicopolitici, affettivi e libidinali della governance ambientale globale e del platform capitalism.
(12 luglio 2017)
Link articolo: Si scrive Antropocene, si pronuncia Capitalocene