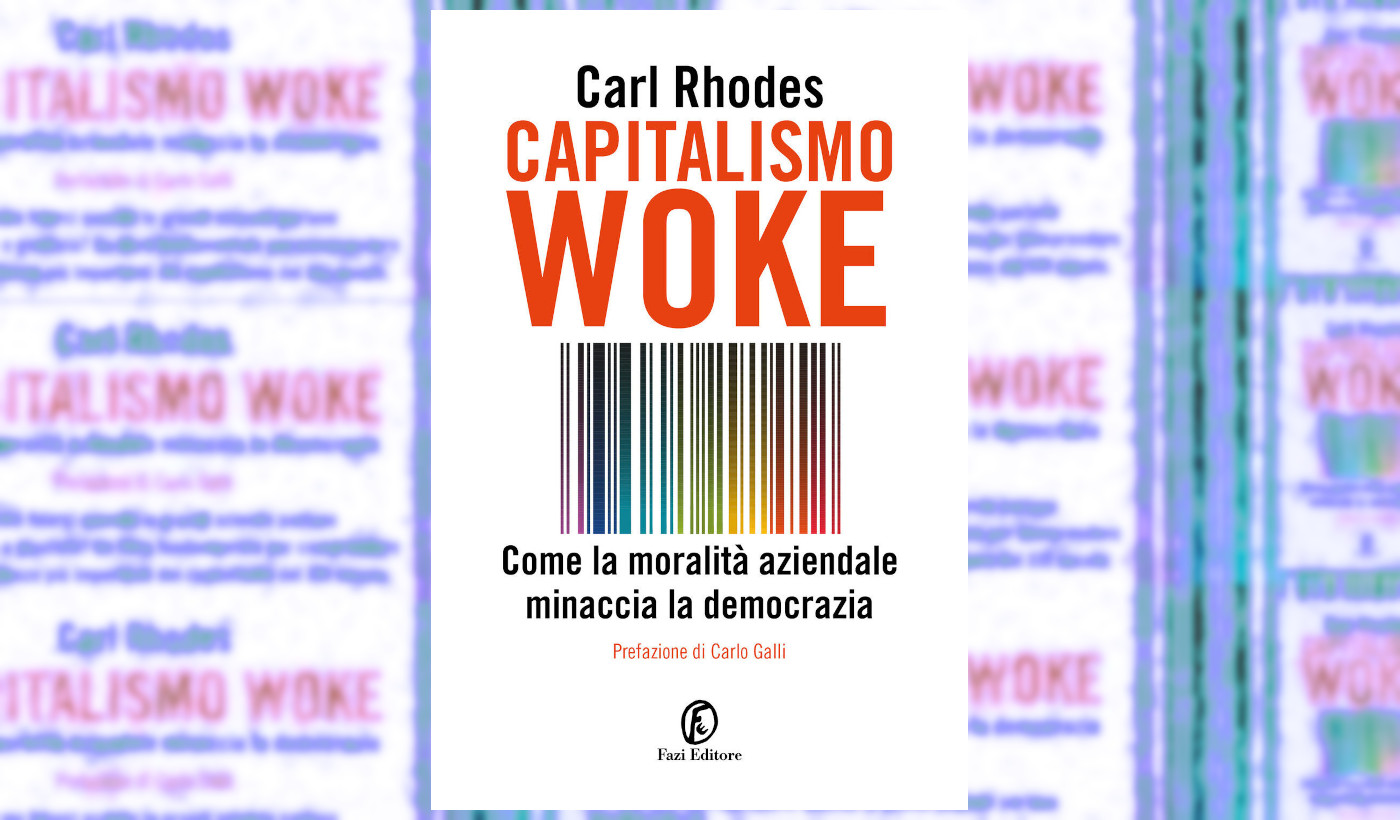‘di Massimiliano Parente
«Nulla è più irrazionale di chi vede tutto in maniera razionale», scrisse Giacomo Leopardi, che tra la luna e la siepe ragionava sull’infinità dell’universo, ancora non così incontrollabile come sarebbe diventato di lì a poco.
Negli anni Sessanta del secolo scorso Italo Calvino analizzò la paralisi dovuta al «mare dell’oggettività », mentre per Carlo Emilio Gadda il mondo era uno «gnommero», un gomitolo inestricabile dominato dall’entropia.
È proprio l’entropia, ovvero la seconda legge della termodinamica, la certezza che qualsiasi cosa proceda dall’ordine verso un disordine, a far entrare in crisi ogni filosofia del centro. Con il Novecento si va di male in peggio, perché si aggiungono le scoperte dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo, la relatività generale e la meccanica quantistica, la casualità della genetica e un universo in espansione infinita. Hans Sedlmayr, storico dell’arte ex nazista, nell’immediato secondo dopoguerra diagnosticò una Perdita del centro (auspicando un ritorno ai polittici gotici, era un tantino conservatore), perdita che sarebbe stata sempre più definitiva.
Così il cosmo, per esempio, diventa un dedalo di significanti senza senso, come in Cosmo, opera del polacco Witold Gombrowicz datata 1965. Preceduto però da Homo Faber, di Max Frisch, romanzo del 1957 che Feltrinelli manda in libreria in questi giorni nella [url”nuova traduzione”]http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/homo-faber-1-2/[/url] di Margherita Carbonaro. Homo Faber non è solo la definizione antropologica dell’uomo artefice, razionale, padrone dei propri strumenti e mezzi intellettivi, ma anche il nome del protagonista Walter Faber. Implicato in una serie di eventi che ne cambiano la vita e la visione del mondo, in una storia da capogiro: prende un aereo, incontra casualmente il fratello di un suo amico, l’aereo cade, insieme vanno a trovare l’amico che nel frattempo si è impiccato, dopodiché una lunga odissea per tornare a New York, lasciare la compagna Ivy che vuole sposarlo, imbarcarsi per Parigi e intrattenere una relazione amorosa con una figlia che Faber non sapeva di avere. Ma la trama conta relativamente, non serve a riempire la vita di significati ma a svuotarla; piuttosto è il modo di vivere di Faber a fare da perno, la sua Weltanschauung, o visione del mondo che dir si voglia. «Non credo alla fatalità o al destino, sono un tecnico, abituato ad affidarmi alle formule della probabilità ».
Tutto quanto accade è solo una possibilità tra le tante, come dice il protagonista: «Non ho bisogno della mistica per considerare l’improbabile come un fatto empirico; mi basta la matematica». Ma il mondo sembra sfuggire alla matematica, alla possibilità di un ordine, come d’altra parte insegna la scienza. Quindi tutta la prima parte del libro è un elenco di disagi fisici, prurito, caldo, sudore, ragni, la barba che cresce e pizzica come un rampicante, le dita che puzzano di alghe e di marciume, l’inospitale deserto del Messico e la fisiologia come metafora di un ordine che non c’è. Faber non sente emozioni, non vuole sentirle, non ci riesce («Non posso mettermi in testa una qualche assurdità pur di provare emozioni»), e ambisce a pensare come un robot, che sta costruendo. In quanto «la macchina non percepisce niente, non ha paure né speranze, che sono solamente un intralcio, non ha desideri in relazione al risultato, e io perciò affermo: il robot distingue più esattamente dell’uomo».
Così qualsiasi stupore è il risultato di una suggestione umana, di un’illusione, tanto quanto guardare a occhi aperti delle piramidi e chiedersi ammirati come abbiano fatto a costruirle gli antichi: «Trovo infantile stupirsi di come avessero portato fin lì i blocchi di pietra – hanno semplicemente costruito delle rampe e levigato poi i loro blocchi con un dispendio idiota di energia umana, proprio questo è l’aspetto primitivo della faccenda».
È il superuomo di Nietzsche con il cilicio al posto del dionisiaco, uno straniero di Camus che non vuole cedere all’assurdo, ma consapevole di quanto non esista facciata luccicante in grado di mascherare la realtà , neppure il sogno americano, tantomeno «the american way of life: un tentativo di cosmetizzare la vita, ma la vita non si lascia cosmetizzare».
La morte, un orrore, ma non per l’idea di finire in sé, quanto per la decomposizione, il terminare nel fango, l’organico disciolto in altra materia organica, in una «putrefazione piena di germi, scivolosa come vaselina, stagni nell’aurora come stagni di sangue lurido, sangue mestruale, stagni pieni di salamandre, solo teste nere con le code guizzanti, come un brulichio di spermatozoi, proprio così – orribile. Voglio essere cremato!». E alla fine del percorso c’è appunto la morte di Faber, o meglio l’accettazione della fine, che sopravviene asettica, poco prima di entrare in sala operatoria, anche questa senza nessuna emozione. Proprio come la ginestra di Leopardi.
Articolo per [url”il Giornale”]http://www.ilgiornale.it[/url] di giovedì 13 aprile 2017.
[url”Link articolo”]http://massimilianoparente.it/lillusione-dellhomo-faber-voleva-un-robot/[/url] © Massimiliano Parente.
Infografica: Max Frisch © L”immagine potrebbe essere soggetta a copyright.
[url”Torna alla Home page”]http://megachip.globalist.it[/url]‘