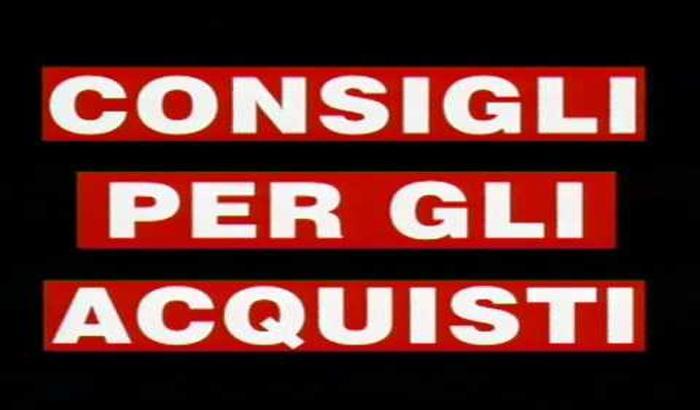di Raffaele Sciortino
Vorrei questa sera socializzare con voi un paio di ragionamenti un po’ a voce alta che almeno in prima battuta non si fermano tanto sulla fenomenologia e su quello che sta accadendo ma cercherò un po’ di metterlo in prospettiva, con dei ragionamenti ad un certo livello di astrazione.
Qui a Torino noi abbiamo avuto la “fortuna” negli anni, rispetto al resto d’Italia, di aver avuto una prospettiva da cui tutte queste dinamiche sociali e politiche in qualche modo erano già tutte in embrione, a partire dal movimento No Tav, poi con Grillo in Valsusa, quindi i forconi. Dunque a Torino ci abbiamo lavorato su già da anni: forse è giunto il momento di cercare di andare più a fondo. In un certo senso come diceva Lorenzo all’inizio, siamo di fronte ad una svolta, una rottura che in maniera peculiare, e se vogliamo anche schizofrenica, mette insieme il movimento No Tav, il movimento dei forconi, il Sud con le sue peculiarità, senza mobilitazione sociale e con una rappresentanza politica di chiara rottura, di nuovo tipo, quindi non è facile inquadrarla.
Un grande sociologo borghese degli anni ‘50 e ‘60, Rokkan, usava il termine “scongelamento” riferendosi a quei momenti storici che avvengono ciclicamente sì, ma non ogni anno o ogni dieci anni, in cui la scomposizione profonda dei blocchi elettorali e anche i risultati elettorali rimandano a delle fratture profonde che si scompongono e potenzialmente si ricompongono a livello sociale e a livello strutturale. E oggi qui in Italia tutto ciò è venuto alla superficie con questo voto, anticipato da quello del 2013 (ma attenzione, parliamo dell’Italia ma abbiamo avuto due anni fa la Brexit, poi Trump, quindi allarghiamo lo sguardo, non fissiamoci solo sull’Italia!).
Prima riflessione: se vogliamo usare il termine populismo, o populismi al plurale, un termine sicuramente inadeguato ma lo usiamo per brevità, possiamo a questo punto tranquillamente dire che i populismi sono qui per restare, per lo meno sul medio periodo, cioè indietro non si torna. Questo è bene averlo presente, anche da un punto di vista strettamente politico. Sono qui per restare non perché si dia una possibile continuità negli attuali contenitori organizzativi, nelle attuali forme, negli attuali personaggi (Grillo, Salvini, Di Maio) ma perché sullo sfondo bisogna tener presente la crisi globale e il fatto che dopo dieci anni non ne sono usciti, tant’è che di fronte alla crisi istituzionale innescata da Mattarella è ricomparso lo spread, è ricomparso l’attacco della stampa internazionale, come se non fosse successo nulla in questi anni dove hanno semplicemente tappato i buchi con la politica del quantitative easing, sia la Bce sia la Federal Reserve negli Stati Uniti. Quindi non è tanto questo, non è questa la continuità del populismo, o dei populismi, che dobbiamo aspettarci, ma la frattura profonda che a loro modo esprimono: il fatto che dentro una crisi profondissima – e qui parlo dell’Occidente – le istanze che una volta erano di classe si sono trasferite dentro un “nuovo popolo”. Quando parlo di istanze di classe intendo le istanze che si esprimono nei diritti sociali ecc., ma anche di una classe, la classe lavoratrice, che innanzitutto non ha più alcuna identità operaia, non ha un’identità come lavoratori. Inoltre non ha più nessuna organizzazione distinta e, in terzo luogo, non ha nessuna prospettiva alternativa, quella prospettiva alternativa appunto che faceva sponda a una tenuta della conflittualità e, pur nel compromesso sociale col capitale, manteneva comunque una distinzione di classe. Tutto ciò è scomparso e i populismi arrivano e portano definitivamente a compimento questo processo.
Quindi quando si parla di morte della sinistra non si sta parlando di tradimento o cose del genere, ma è la cronaca di una morte annunciata perché si è all’ ultimo o a uno degli ultimi episodi di questo percorso, di questo processo storico – che, ripeto, non è esclusivamente italiano al di là del fatto che nelle varie situazioni nazionali si dà in maniera differente, variegata. Quindi il populismo raccoglie queste istanze di classe, ma di una classe completamente sciolta, liquida, nella completa subordinazione al rapporto di capitale, per i motivi che dicevamo. Questo è il punto di non ritorno ed è la scaturigine vera della fine della sinistra, per cui noi assistiamo in questi populismi ad un mix, da una parte, di cittadinismo, vale a dire il cosiddetto populismo di sinistra, non quello dei partitini ma quello radicato dentro la base sociale e elettorale, i militanti dei 5stelle. Una sorta di cittadinismo che paradossalmente eredita il movimento no global e tutte quelle istanze che seguono, e che abbiamo visto in opera proprio dentro il movimento No Tav, una ad una, in maniera molto chiara e combattiva.
Dall’altra parte, abbiamo l’interiorizzazione delle regole, dei diktat del neoliberismo. Però questa interiorizzazione dopo dieci anni di crisi non è che ha cancellato la necessità di reagire, però questa necessità di reagire si dà come una sorte di illusorio “uso dal basso” delle regole stesse del neoliberismo. Del resto ricordiamoci che quando scoppiò la crisi nel 2008/2009, l’unica reazione specificatamente operaia che abbiamo visto sono stati gli operai, soprattutto delle piccole e medie aziende, che salivano sui tetti e chiedevano «un manager capace». Quindi non è solo questione di ceti medi, ceti medi declassati, ma è di tutti, di questa massa ormai iper-proletaria che siamo diventati o stiamo diventando tutti. Quindi questo mix peculiare che costituisce questo nuovo popolo, non saprei neanche come definirlo, ci pone davanti ad un periodo complesso, ancorché interessante, in cui le due tendenze vanno insieme, un po’ si discostano, un po’ si incrociano, un po’ si sovrappongono.
Le due tendenze sono: quella della disgregazione del tessuto sociale, del legame sociale, proprio perché ormai il capitalismo ha permeato di sé, delle proprie relazioni, non solo più la produzione e la circolazione, ma la riproduzione complessiva del sistema sociale, quindi te lo trovi dappertutto – non apriamo poi il capitolo del nuovo macchinismo digitale che ne è una conferma eclatante. Questo, insieme al venir meno del conflitto come lo abbiamo conosciuto nel vecchio movimento operaio, fa sì d’altro canto che permangano delle ambivalenze, quelle che richiamava Marco Revelli nel suo intervento, su cui peraltro abbiamo lavorato in questi anni, per cui chiusura sì ma richiesta di diritti sociali, con una rottura in qualche modo delle compatibilità date (non, chiaramente, quelle capitalistiche). Queste dinamiche nel bene e nel male hanno aspetti con istanze positive, condivisibili, e con chiusure con aspetti ambigui se non proprio negativi. È a questo che ci dobbiamo preparare perché con la sinistra e con il vecchio movimento operaio finisce anche il progressismo, cioè finisce la prospettiva di avere un terreno comune tra lavoro e capitale che conflittualmente possiamo guadagnare e su cui possiamo ottenere miglioramenti: questa prospettiva è finita. È qui che iniziano i problemi perché le ambivalenze sono qualcosa di meno della classica contraddizione di classe, che seppur nel ‘900 ha portato – nel passaggio fascismi-democrazia – al compromesso sociale fordista, ai trent’anni gloriosi e così via, comunque sia manteneva ciò che dicevo prima, cioè una distinzione tra classi, dei progetti e anche una prospettiva in qualche modo alternativa: questo è scomparso.
L’ambivalenza è meno della contraddizione classica. Però se ci pensiamo mentre con la contraddizione classica, di classe, in qualche modo si addiveniva sempre ad un compromesso, cioè si giocava alla fin fine sul terreno del capitale, per conquistare spazi nostri, ma alla fine a furia di conquistare questi spazi dentro il capitale – questa è stata la fondamentale dialettica del lungo Sessantotto – ci si è trovati completamente immersi, del tutto subordinati e permeati, perdendo consistenza di classe distinta. Quindi la contraddizione è scomparsa, rimangono le ambivalenze che spesso e volentieri sono ambiguità, che sono però più vicine ai nodi profondi e strutturali di questo modo di produzione, perché certe cose che noi non sentivamo più, cui non si accennava più, dopo la sconfitta del 68, paradossalmente le abbiamo sentite da Grillo piuttosto che da altri: si lavora troppo, la decrescita, ecc., basterebbe qui analizzare ciò che è venuto fuori dal movimento No Tav…
Per concludere su questo primo punto, ripeto, ci troviamo di fronte ad un momento di non ritorno che in qualche modo segna anche l’esaurimento del lungo ciclo del Sessantotto, di questo Sessantotto che in qualche modo ha subito una strana sconfitta, strana perché molti dei suoi momenti, delle sue dimensioni sono state perversamente assunte dal capitale. Dunque mentre il Sessantotto ha esaurito il movimento operaio classico, mettendo in campo, almeno in un primo momento, il tema dell’ autonomia declinata su tutto lo spettro della società: dall’ autonomia operaia all’ autonomia femminile, e via discorrendo – a questo punto, se è vero che siamo di fronte ad una società completamente permeata dal rapporto di capitale, non è più possibile nessuna autonomia di classe; e anche chi presume di avere una autonomia giocata su altre identità singole, ad esempio identità di genere, identità individuale (perché non ci interessa più l’organizzazione collettiva) deve fare i conti con il fatto che anche questa dimensione si avvia a conclusione. Questi sono i paletti dunque per capire dove siamo, anche in prospettiva storica.
Seconda riflessione: scendo un pochino giù di livello di astrazione ed entro un po’ più nel merito: mi rifaccio a quel che è successo negli Stati Uniti per l’evidente importanza che ciò riveste. Quando Trump ha fatto campagna elettorale ed è stato eletto, conosciamo le reazioni che ci sono state: è un pazzo, un fascista, e così via. Per quel che mi riguarda, anche sentendo un po’ di compagni dagli Stati Uniti, quelli che non sono completamente diventati liberal – in effetti, in tutti questi anni anche la sinistra antagonista ha necessariamente interiorizzato molti paradigmi, molti criteri della sinistra liberal – bene, loro dicevano che stava veramente succedendo qualcosa di non catalogabile nei consueti modi.
In estrema sintesi negli Usa, Trump – al di là del personaggio, di cui potrebbe non interessarci proprio niente – è insieme espressione di una dinamica sociale profondissima, di quelle parti della società che presumono di non poter più guadagnare dalla globalizzazione, neanche nel centro dell’ impero, quell’ impero che vive a debito e con l’esuberante privilegio del dollaro – ciò è importantissimo perché siamo negli Stati Uniti e non nell’ Italietta… – ma è anche espressione di una parte dell’establishment (che è uscito allo scoperto non appena il change obamiano è fallito) che ha capito benissimo che se gli Usa devono continuare a dominare, a sfruttare il mondo, bisogna cambiare strategia. Su quali elementi? Su due elementi: primo, la geopolitica, e infatti vediamo che gli Usa sono diventati la prima potenza revisionista, devono rimettere tutto in discussione, perché solo così possono evitare che l’antagonista cinese si rafforzi. Il tempo brucia per gli Stati Uniti, non possono permettersi di lasciare ulteriore tempo alla Cina, e poi l’ attacco alla Russia – qui il discorso si fa più complesso ma non possiamo affrontarlo adesso – e ormai si è arrivati al cuore dell’ Europa, cioè alla Germania che per gli Stati Uniti di Trump è un antagonista, non dico come la Cina, ma in qualche modo più attaccabile. Secondo elemento: la politica economica, perché quello che è in gioco in questi passaggi politici è il “post-quantitative easing“, la Fed infatti sta alzando i tassi, e non è detto che non succeda un nuovo Volker-shock, quello del 1979-80 quando per uscire dalla crisi – tra Vietnam, lotte operaie, movimento, donne, lotte anticoloniali, poi Watergate e ancorala crisi dell’amministrazione Carter con la rivoluzione in Iran, il secondo shock petrolifero, la rivoluzione in Nicaragua: insomma gli Stati Uniti si erano profondamente indeboliti, certo in un’altra fase, ancora bipolare – ad un certo punto arriva Reagan e il presidente della Fed Volker alza drasticamente i tassi, risucchia capitali da tutto il mondo, mette in crisi il nuovo ordine mondiale che cercava di emergere, mette in crisi l’Unione Sovietica, e deprima tutta un’ ondata di lotte che già andava scemando (ricordo solo l’’80 alla Fiat).
Chiusa parentesi. Ci sono dunque in ballo cose grosse, cioè il “dopo-quantitative easing“, il dopo “denaro facile” e qui assistiamo ad una recrudescenza dello spirito competitivo del mercato. In qualche modo la globalizzazione che ci hanno venduto dagli anni Novanta in poi, quella a suo modo cooperativa – per i capitali – è finita, adesso c’è la globalizzazione competitiva. Con questo voglio dire che in queste svolte abbiamo sempre un’esigenza dall’alto e un’esigenza dal basso, un’esigenza dell’establishment di cambiare strategia e quella dal basso che appunto, in un certo senso, Obama aveva cercato di captare.
Per l’Italia questo discorso diventa più complesso perché mentre per ciò che riguarda l’ esigenza dal basso è chiara, è quello di cui abbiamo parlato fino ad ora ed è sotto gli occhi di tutti, in alto cosa è rimasto? È come se ci fosse una casella vuota, almeno, può darsi che si riempia o che noi non riusciamo a vedere bene, ma è chiaro che l’Italia si è fortemente indebolita in questa crisi globale – 25% in meno di produzione industriale, 10% in meno di reddito pro-capite, ha perso completamente la Libia, sanzioni alla Russia che la danneggiano – siamo di fronte a un declassamento pazzesco e l’Italietta rischia di finire veramente in serie C. Dunque mi chiedo se di fronte a tutto questo e di fronte alla rappresentanza politica che di ciò deve comunque tener conto e cercare di farsi sentire in Europa, non è escluso, non solo per il classico trasformismo italiano, che potrebbe esserci qualcosa di più profondo: una parte dell’establishment si rende conto che quando Draghi finisce con il quantitative easing… che si fa? L’Italia non ce la fa e si frantuma territorialmente e socialmente?
La differenza tra gli Usa e l’Italietta è che davanti a questi sovvenimenti il problema per la borghesia è come trasformare questo neo-popolo, liquido ma che inizia a essere più reattivo, anche solo nella forma rancorosa, come trasformarlo in nazione da usare contro le altre nazioni nella competizione crescente. Dunque tornando all’Italia e alla svolta sotto i nostri occhi, vediamo che è stretta tra Usa e Germania (o Europa): Savona è un filo-americano antitedesco, ma al tempo stesso un governo italiano quando Trump impone i dazi e dice: «con la Russia non provate a trattare», come fai a far sponda sugli Stati Uniti? E, attenzione, gli Usa osservano e su questo puntano, per distruggere definitivamente Euro ed Europa. Al tempo stesso cresce l’atteggiamento antitedescho, e la Germania è sempre meno capace di fare la vera egemone, in senso gramsciano se vogliamo. Quindi si sta presentando uno scenario che può essere anche da incubo, rispetto allo stesso 2011. Mi fermerei qui con queste questioni che mi rendo conto partire da considerazioni un po’ astratte, un po’ generali ma che mi sembra possano servire per prendere, appunto, le misure della situazione.
In ultimo: per introdurre la discussione, a questo punto non mi concentrerei tanto sul fatto se questo governo sia più o meno conseguente, perché visto in prospettiva è chiaro che i populismi intanto sono amici del popolo in quanto si contrappongono a qualcun altro, sia all’interno che all’esterno, e puntano soprattutto all’esterno per tenere compatto il popolo, ben al di là della questione migranti. Il problema invece è lo scarto che c’è tra i loro programmi e le loro promesse da un lato – che non sono una presa in giro perché in Europa c’è da contrattare, e in Italia c’è da far fuori tanto parassitismo, tanti sprechi – e la situazione oggettiva che si va complicando a livello globale e nel rapporto tra Europa e Stati Uniti, come dicevamo prima. Questo è il criterio da utilizzare per abbordare le prospettive politiche. E in questo è demenziale pensare di fare i populisti di sinistra, cioè di mettersi sulla medesima direttrice del populismo e però essere più conseguenti. Non valeva nemmeno per il riformismo operaio classico, questo criterio, figuriamoci adesso. Sono cambiate proprio le coordinate.
Il problema è questo: a quali condizioni nell’incasinamento generale e globale, le istanze di classe che oggi stanno dietro o a rimorchio o che spingono il populismo, i populismi, a quali condizioni possono dislocarsi su un terreno diverso, potenzialmente anticapitalistico, e dunque trasformarsi a fondo? Tenuto sempre conto che i soggetti sociali che oggi stanno dietro il populismo sono quelli che ci interessano. È da qui che, anche nell’isolamento all’inizio, siamo partiti…
(7 giugno 2018)
Il testo è stato pubblicato su Infoaut il 10 luglio scorso.