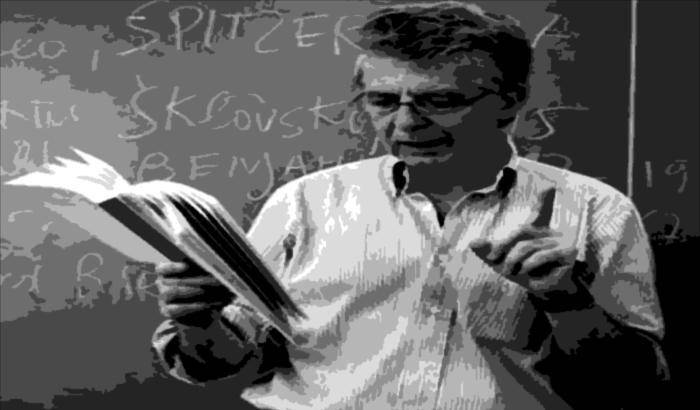Lunedì 26 ottobre (ore 17.00), al Teatro Argentina di Roma, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del [url”Premio Nazionale Elio Pagliarani”]http://www.premionazionaleeliopagliarani.it/[/url]. Abbiamo incontrato Cetta Petrollo, Presidente del Premio, per farle alcune domande su questa nuova iniziativa e sullo “stato di salute†della poesia in Italia.
[center]***[/center]
La prima edizione del Premio Nazionale Elio Pagliarani volge al termine. Lunedì prossimo ci sarà la premiazione dei vincitori al Teatro Argentina di Roma. Può illustrarci le motivazioni del Premio e farci un primo bilancio dell’iniziativa?Le motivazioni del premio sono quelle descritte nel documento fondante redatto nel 2014 a firma di Andrea Cortellessa, Roberto Milana, Lia Pagliarani e Sara Ventroni: “Ricordare un Maestro significa per noi anzitutto selezionare e valorizzare – nel panorama delle creatività odierne – coloro che in qualche modo e per qualche verso ci paiano meglio raccogliere il suo testimone. Un inciso, da Lezione di fisica, suona: «perché l’opposizione agisca da opposizione e abbia i suoi testimoni». Di opposizione fu l’esistenza di Pagliarani, sempre: in quanto la sua parola – sempre pervasa tuttavia dalla più umana e profonda «pietà oggettiva» – si oppose, sempre, all’andazzo (oggi più ammorbante che mai) di una comunicazione appiattita sul luogo comune, di una letteratura asservita al più facile consumo, di una poesia appagata del proprio ripiegamento autocommiseratorioâ€.
Quando si parla di Elio Pagliarani è automatico pensare anche al [i]Gruppo ’63[/i] e a quella stagione del dibattito culturale italiano che ha visto l’emergere delle avanguardie del dopoguerra. Lei pensa che ci sia ancora spazio oggi per portare avanti un discorso di avanguardia nella letteratura e nella poesia in particolare? E se sì, in che modo?Sicuramente c’è ancora spazio per ascoltare la lingua che si muove intorno a noi – non solo letteraria! – e centrifugarla e portarla altrove, rompendo gli ambiti (che è una delle grandi ambizioni dell’avanguardia).
Guardando al panorama delle iniziative italiane che promuovono la diffusione e la conoscenza della poesia sul territorio, anche in una prospettiva multi-tematica e di ricerca – penso, ad esempio, a [i][url”Poetitaly”]http://s534509712.sito-web-online.it/[/url][/i] di Simone Carella e a [i][url”Bologna in Lettere”]http://boinlettere.wordpress.com/[/url][/i] di Enzo Campi –, Lei pensa che ci si stia muovendo nella direzione giusta o bisognerebbe aggiustare il tiro? Insomma, esistono ancora luoghi dove il pubblico può “incontrare†la poesia e vederla dialogare con altre espressioni dell’arte? O forse tali luoghi non ci sono mai stati e siamo destinati, ieri come oggi, all’autoreferenzialità delle “scuole†e degli [i]horti conclusi[/i]?Se penso a quello che ha significato scrivere e dire poesia negli anni Sessanta e Settanta, alla coralità della sua azione, alla sua incidenza politica attraverso lo specifico linguistico, al rapporto vitale fra artisti, poeti e gente comune in luoghi non esclusivamente deputati alla diffusione della cultura, a cosa hanno significato in ciò le dinamiche cittadine – a Roma, per esempio, la funzione di bar come Canova, Rosati e Felicetti, le trattorie come Cesaretto, i ristoranti come la Campana, le strade come via Mario dei Fiori e Via Margutta, abitate anche da gente qualsiasi e dal modesto reddito, credo che la direzione non sia, forse, quella giusta ma che il processo sia inevitabile giacché quel tessuto sociale è stato distrutto e la poesia, l’arte tutta ed i poeti, si siano ritirati nelle loro riserve indiane molto più di quanto non sia, in qualche modo, sempre accaduto.
E poi è anche vero che, per fare laboratorio e crescere portando una qualche forma di messaggio (“credere che il proprio lavoro la pena non se stessi ma il proprio modello sia utile / agli altriâ€) occorrono grandi personalità . E grandi voci. È molto raro. Non succede sempre.
Restando all’attualità , nelle ultime settimane abbiamo assistito sulle pagine culturali di alcuni quotidiani e magazine online a un riaccendersi del dibattito sulla sorte di poeti e poesia (soprattutto in chiave editoriale). Alfonso Berardinelli ha affermato che in Italia “di poeti pubblicabili cioè leggibili (anche se poco vendibili) ce ne sono circa una dozzina, magari anche venti, o se proprio si vuole si arriva a trentaâ€. Andrea Cortellessa ha parlato di “poeticidioâ€, sostenendo la necessità imprescindibile “per la cultura editoriale italiana†di avere “l’accesso a finanziamenti pubblici come quelli da decenni riservati, all’editoria di qualità (non necessariamente cartacea), da diversi Stati europeiâ€. Lei che idea si è fatta di tutta questa polemica?Non credo che i finanziamenti pubblici possano aiutare la scrittura poetica e l’arte in genere. Si può, certo, commissionare un’opera d’arte, ed è quello che hanno sempre fatto i mecenati. Tutta la nostra arte religiosa ha le sue origini nelle commesse della Chiesa. Non sono tanto d’accordo sul correre il rischio delle edizioni poetiche “su commissioneâ€.
Credo che la scrittura e l’editoria si possano aiutare e sostenere in altro modo. Finanziando, per esempio, i luoghi deputati alla conservazione delle opere. Rompendo, anche qui, gli ambiti fra scuola, studenti e contesto, in un laboratorio continuo in cui i testi possano essere letti, elaborati digitalmente, compresi nella galassia linguistica e possano comprendere altri linguaggi.
Ringraziandola per averci concesso un po’ del suo tempo per questa intervista, Le faccio un’ultima domanda. Se oggi un ragazzo o una ragazza le chiedessero un consiglio di lettura per avvicinarsi alla poesia italiana, cosa gli risponderebbe?Consiglierei Inventario privato e gli Epigrammi ferraresi di Elio Pagliarani. Un modo diverso per scrivere d’amore e di politica.
(22 ottobre 2015) [url”Torna alla Home page”]http://megachip.globalist.it/[/url]