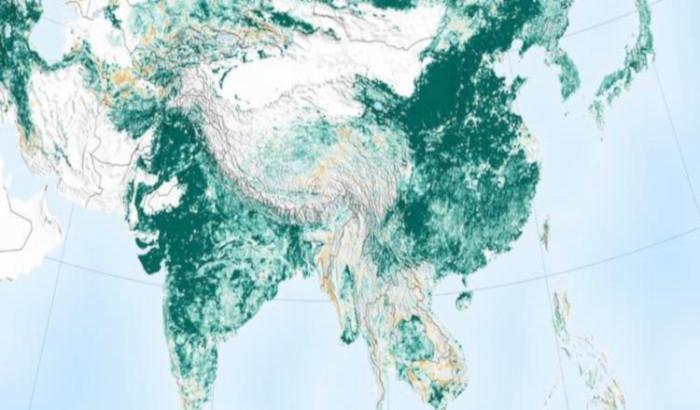La questione in gioco in [i]Stato di morte apparente[/i] (Cortina Editore, Milano 2011, pp. 150, 12 €) è quella di una resistenza. Una resistenza stilistico-antropologica che risponde a un’urgenza: se la globalizzazione predetermina il filosofo, i suoi codici e le sue semantiche, le sue interconnessioni tecnologiche, i suoi corpi e i suoi desideri, cosa resta della filosofia? Quali spazi e quali tempi le restano affinché essa possa, almeno parzialmente, de-globalizzarsi?
Il tema delle pratiche connesse all’autotrasformazione tramite esercizio, molto presente nell’ultimo Sloterdijk, tocca qui il suo climax, poiché è fatto convergere nella figura del filosofo-che-si-esercita-filosofando:
«il soggetto, concepito come esecutore delle proprie sequenze di esercizi, consolida e potenzia il suo saper-fare sottoponendosi agli esercizi tipici del suo contesto» (p. 34).
L’esercizio dell’[i]homo theoreticus[/i] è del tutto particolare, dato che si struttura sempre entro un rapporto complesso col fittizio (Schein) e con la morte (Tod), e il libro ripercorre l’innesto paradossale della morte apparente (Scheintod) nel gesto di auto-sospensione alla base dell’atteggiamento teoretico.
Sloterdijk traccia le condizioni di possibilità e la genealogia storica di tale esercizio (auto-sottrazione dall’esistenza a favore dello spazio vuoto del concetto), sino al suo sviluppo estremo: il rifiuto del teoretico puro tipico dell’epoca contemporanea. L’eco di tale auto-contraddizione performativa risuona nelle conclusioni del libro, e oltre: che segno dare a tale uccisione dell’osservatore puro? Uccidere un morto? Resuscitare un morto apparente? È un contro-esercizio dentro l’esercizio dal vago sapore nietzschiano: ironico e tragico, ineffettuale e inattuale, e, d’altra parte, necessario.
Ricreare una propria forma, e ciò vale per lo stesso Sloterdijk, in un acrobatico rimettersi in forma: tale prospettiva forte non rischia di ripristinare una mera filosofia soggettocentrica? Va interrogato allora il nodo della relazione essenziale del soggetto-filosofo con la globalizzazione. Non si tratta solo di una relazione reattiva, cioè di opposizione. Per quanto difficile da pensare, essa è anche una relazione di intreccio con la macrosfera globale. Infatti il soggetto è processo, processo antropotecnico; in questo senso è sempre una trama aperta al mondo e al tempo: le tecniche che lo definiranno nell’esercizio gli sono co-originarie, in quanto già collocate nel mondo culturale da cui il soggetto deriva. Le tecniche registrano le mutazioni storiche e tecnologiche e le incorporano nel soggetto-filosofo, anche a sua insaputa.
Qui entra in gioco la questione dello stile di Sloterdijk come opzione di resistenza filosofico-antropologica. Nella scrittura della pagina e soprattutto nell’orchestrazione complessiva, c’è qualcosa che resiste alla lettura lineare, che pospone il senso, e che, pertanto, sospende il legame filosofia-globalizzazione.
L’esercizio narrativo riattraversa la filosofia, intesa come forma (prodotto o spettro) della globalizzazione, dipingendone nuove morfologie. In questo processo, che è filosofico nella misura in cui è antropotecnico, va cercato il senso del de-posizionamento di Sloterdijk rispetto al problema dell’inglobamento del filosofo. Lo stile prevede, infatti, una reinscrizione di elementi “filosoficiâ€, insieme ad altri non filosofici, entro uno spazio teatrale e narrativo che tende a risignificarne le funzioni e a determinare novità . L’esercizio ultimo – quello del filosofo su se stesso – produce novità nel globale, precisamente nel suo riassetto formale: un ri-posizionamento degli artefatti filosofici della globalizzazione.
Basterà leggere qualche pagina per capirlo: Husserl e Socrate sono innanzitutto attori nel teatro di Sloterdijk regista-filosofo. Agiscono sul medesimo palco, uno recitando l’epoché (de-esistenzializzazione propedeutica alla speculazione pura), l’altro le sue grottesche e proverbiali assenze mentali. Accostarli è immotivato, in un’ottica “filosoficaâ€. Tuttavia proprio in quel vuoto logico Sloterdijk guadagna le sue possibilità di stile: accompagnare il lettore, riassemblare in senso cubista gli elementi filosofici, offrire inediti affreschi concettuali mediante i quali operare un ripensamento del concetto di ritiro dal mondo, associato allo Scheintod.
Oltre a dirigere gli attori, Sloterdijk mescola costantemente i piani, taglia le scenografie e vi innesta altri fuori-scena: le assenze di Socrate conducono al motivo generale dell’assentarsi dalla polis; ma questo inaugura l’essere-sempre-altrove del teoretico rispetto al politico; di qui si irradiano inaspettatamente altre linee narrative, come quella dell’urbanistica filosofica, delle sue ricadute sull’habitus globale dell’allievo connesso poi alla crisi globale della democrazia:
«dove in passato si svolgevano i dibattiti dei cittadini, dissertano adesso i visiting professor e il mondo intero è diventato il loro pensionato» (p. 89)
mentre, nella scena precedente, avevamo sorpreso Husserl nel suo carteggio col poeta Von Hofmannsthal. Avanscena di cuiresta da comprendere il nesso con il seguito.
Lo stile è quindi ciò che resta, che resiste alle leggi globali, codificate nell’ortodossia dell’esercizio filosofico puro, e, forse, alle stesse tesi di Sloterdijk; configura una forma di grande narrazione (p. 137) capace di sospendere la percezione concettuale del consumatore di lettura, anche solo per un istante. Sloterdijk resta dentro la sfera globale, ma al contempo le resiste, esponendola a mutazioni lente, dilatandone le maglie: prendendo (il) tempo.
[url”Torna alla Home page”]http://megachip.globalist.it/[/url]