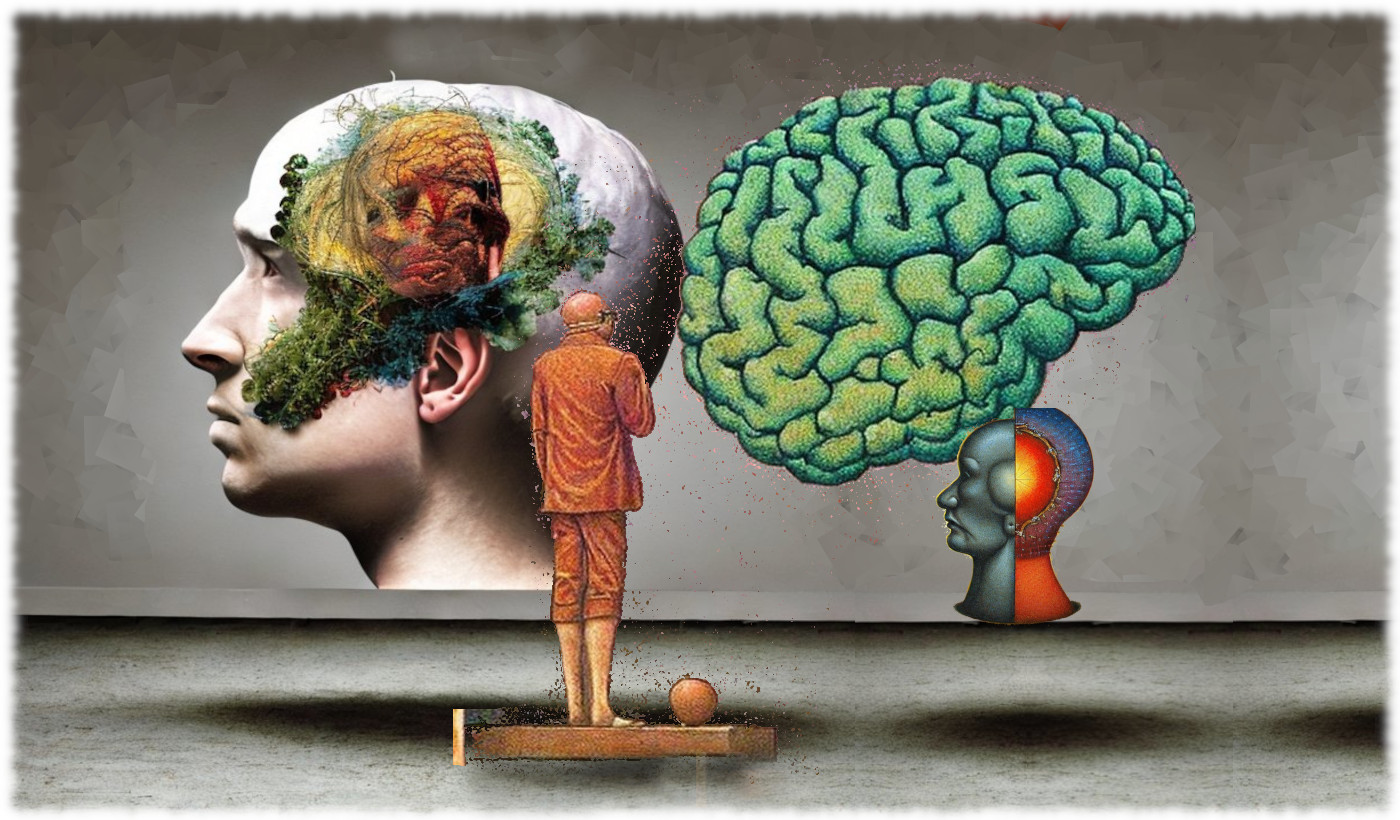Paolo Bartolini intervista Francesco Remotti, antropologo italiano di fama internazionale, professore emerito di Antropologia culturale presso l’Università di Torino. Dal concetto di antropo-poiesi alla critica radicale all’ideologia dell’identità , uno sguardo critico sull’Occidente e sulle forze impersonali che lo guidano. Buona lettura. (pfdi)
[center]***[/center]
Dobbiamo a lei e ai suoi collaboratori l’affermarsi, nelle scienze umane e sociali, del concetto di antropo-poiesi (secondo il quale ogni cultura costruisce i propri umani, dando loro una forma specifica compatibile con le aspettative del gruppo di appartenenza). Potrebbe illustrare quelli che sono i risvolti più politici di tale concetto?Ridotta ai minimi termini – inevitabilmente ruvidi e sbrigativi – la nozione di antropo-poiesi significa “mettere le mani sugli uominiâ€, sugli individui della nostra specie. Possiamo rendere efficacemente il verbo greco poiein, da cui “poiesiâ€, con “manipolareâ€: e questo “manipolare†e, prima ancora, “mettere le mani su†sono senza dubbio manifestazioni di potere, di un grande potere. Da parte di chi? È evidente che l’individuo impiega molto tempo prima di giungere alla consapevolezza di poter dare una qualche forma a sé stesso (alla propria vita, al proprio corpo, alla propria mente). Nel lungo tratto di tempo che lo separa dalla nascita a questa soglia di consapevolezza, l’antropo-poiesi è tutt’altro che assente: anzi, questo è il periodo in cui maggiormente si esercita il potere antropo-poietico degli “altri†su un soggetto inconsapevole, indifeso, malleabile, molto plastico. Gli altri sono in primo luogo coloro che si prendono cura di lui e lo fanno crescere: non solo genitori, nonni, altri parenti, ma anche – come spesso avviene nella nostra società – figure professionali di educatori che accudiscono i piccoli nei “nidi†infantili, negli asili, nelle scuole. A loro volta, tutte queste persone non agiscono in un vuoto culturale: sono immerse in una società nella quale si sviluppano idee, temi, valori, scelte di chiara rilevanza antropo-poietica (dal tipo di cibo all’abbigliamento, dai modelli di comportamento maschili e femminili ai criteri igienici e sanitari, dai valori etici a quelli estetici, dai programmi pedagogici a quelli politici). Sono molte le agenzie formative nelle società e, anche se i loro obiettivi sono apparentemente di altro tipo (per esempio, economici, ludici e così via), la loro incidenza sul piano antropo-poietico può essere molto grande. In particolare, si pensi quanto profonde siano le implicazioni formative delle religioni, sia sul versante ideologico, sia su quello comunitario. Infine, il potere politico. Non c’è dubbio che i regimi totalitari perseguono obiettivi antropo-poietici in maniera programmata, esplicita, sistematica e, appunto, totalitaria. Ma anche i regimi più liberali – quelli che maggiormente affidano agli individui compiti autoformativi – non sono certo esenti da risvolti antropo-poietici, espliciti o impliciti che siano. E gli individui? Trascorrono gran parte della loro vita in un estenuante tiro alla fune tra i condizionamenti ambientali, ovvero i fattori antropo-poietici esterni, a cui sono esposti fin dalla nascita, e l’esigenza di autonomia e di liberta, con cui cercano di dare senso alla loro esistenza.
I suoi lavori più recenti riguardano la critica radicale all’ideologia dell’identità . Per andare oltre alle chiusure che si generano evocando un “noi†contrapposto a gli “altri†lei ha suggerito, discutendo della costruzione di soggettività , di parlare di somiglianze e differenze interne ed esterne al singolo individuo. Può approfondire questa promettente pista di ricerca che l’ha condotta al nuovo concetto di “SoDifâ€?Ho pensato un bel po’ prima di decidermi a proporre questo termine così artefatto e forse anche cervellotico. Ho inteso coniare un’unica parola, mettendo insieme la sillaba iniziale di “somiglianza†e la sillaba iniziale di “differenzaâ€, allo scopo di far capire quanto “somiglianza†e “differenza†si implichino a vicenda (come se fossero le due facce di una stessa medaglia), e come sia perciò impossibile parlare di somiglianza senza evocare anche la differenza. Sono arrivato a scoprire il valore della somiglianza, quando, dopo avere proseguito nella mia critica al pensiero identitario, mi ero accorto che era indispensabile, e non solo opportuno, proporre un concetto alternativo, che ci consentisse di transitare verso un altro modo di pensare. In maniera radicale: se io non sono identico a me stesso, se la mia identità personale è in realtà una “finzioneâ€, quale tipo di rapporti intrattengo con me stesso? Come ci insegnano sia Hume sia il personaggio di Diotima nel Simposio di Platone, io non sono identico, sono invece “simile†a me stesso: il mio io è fatto di rapporti interni di somiglianza e di differenza; l’io è un complicato, elaborato, spesso anche un po’ squilibrato SoDif interno. La strada più radicale è quella che spinge il SoDif molto all’interno, senza pensare che in fondo all’io ci sia un nucleo duro, compatto, inscalfibile, fatto di sola identità . In un lavoro dedicato al concetto di io Douglas Hofstadter giunge anche lui alla conclusione che tra il D.H. di ieri e il D.H. di oggi non c’è un rapporto di identità , ma di somiglianza: o meglio, di somiglianza e di differenza, SoDif appunto.
Quanta somiglianza e quanta differenza? Ovviamente, è una questione di gradi: è assai probabile che ci sia molta più somiglianza tra il “me†di oggi e il “me†di un anno fa, che non tra il “me†di oggi e il “me†di quarant’anni fa. Ed è anche probabile che ci sia più somiglianza – almeno per certi versi – tra il me di oggi e qualche altra persona a me vicina o intima, che non tra il me di oggi e quello di tanti anni fa. A quanto pare, non esistono barriere del tutto insuperabili: in un modo o nell’altro le somiglianze trapassano le barriere. Se l’io è un SoDif molto mobile e dinamico, i suoi confini sono piuttosto convenzionali e arbitrari. I Kanak della Nuova Caledonia – studiati da Maurice Leenhardt – sostengono che la persona non coincide affatto con un nucleo interno: consiste invece in un fascio di relazioni con gli altri esseri; e si badi, non solo con altri esseri umani, ma anche con altri esseri viventi, animali e vegetali. La persona non è una sostanza, è una rete di relazioni: è un SoDif interno ed esterno nello stesso tempo. A questo riguardo, gli antropologi hanno cominciato a parlare di concezione “dividuale†della persona: non solo i Kanak, ma molte altre società nel mondo concepiscono gli esseri – anche gli esseri umani – non come “in-dividuiâ€, ma come “dividuiâ€, tra cui si svolgono rapporti sia di somiglianza sia di differenza.
Ma qui c’è un punto da aggiungere. Qualunque cosa noi facciamo, pensiamo o sentiamo, provochiamo una qualche modifica del SoDif sia interno sia esterno: aumentiamo o diminuiamo la componente So o la componente Dif, sia con noi, sia con gli altri. L’ideologia identitaria allora che cos’è? È un pensare che le somiglianze interne (a un Io o a un Noi) possano essere aumentate fino al punto di trasformarsi (illusoriamente) in identità . In maniera corrispondente, vengono annullate le somiglianze con gli Altri (i nostri simili) e le differenze sono trasformate in alterità : non più SoDif, ma opposizione tra identità e alterità . Con le conseguenze disastrose che ne derivano: inaridimento delle relazioni con gli altri (non più “similiâ€, ma “altriâ€), con cui c’è ben poco da condividere; trasformazione degli altri in potenziali nemici, in minacce per la nostra identità ; adozione di strategie di difesa, di arroccamento, di respingimento, di annientamento.
Una persona con la sua esperienza, avvezza per vocazione e per mestiere al contatto con mondi differenti dal proprio, cosa intravede nel momento in cui è chiamata a rivolgere uno sguardo antropologico proprio sull’Occidente e sulle forze impersonali che lo guidano?Questa è una domanda troppo difficile. Per fortuna, mi si chiede che cosa riesco a “intravedereâ€. Tento di rispondere, mettendo insieme alcune idee espresse prima, in particolare combinando l’antropo-poiesi e le somiglianze. Antropo-poiesi vuol dire dare una qualche forma all’umanità (sia a livello della persona singola, sia a livello collettivo: società , culture, civiltà ). Dare forma, a sua volta, significa avere di mira, inventare, imitare un qualche modello “per†l’umanità . I modelli, a loro volta, oltre che essere elaborati di continuo nella vita sociale, possono essere “inventati†rivolgendosi alla natura (piante, animali), al passato (antenati), ad altre società (vicine o lontane che siano) o a entità sovraumane (spiriti, divinità ). Di questi tempi, sono molto interessato a collegare la modernità occidentale al cristianesimo antico: c’è un legame profondo, c’è continuità nella loro progettazione antropo-poietica. Questo legame può essere intravisto nel concetto di deificatio, nell’aspirazione a diventare sempre più simili a Dio, a diventare noi stessi Dio. In quali modi? Ne indicherei tre: a) dominando sempre più la natura; b) vincendo la morte; c) acquisendo noi stessi il ruolo di creatori. Non c’è bisogno di essere credenti per partecipare a questo programma antropo-poietico, che di continuo porta fuori dai confini dell’umanità , verso la divinità che noi stessi abbiamo inventato e a cui attribuiamo il primo passo di questa (probabilmente folle) avventura: è la “nostra†divinità ad averci fatti “a sua immagine e somiglianzaâ€. L’ateismo moderno potrebbe essere concepito come il segno del compimento di questa avventura, che coincide con l’idea di scalzare la stessa divinità , di prendere il suo posto. Lo storico Yuval Noah Harari ha scritto un libro dal titolo molto significativo: Da animali a dèi. Breve storia dell’umanità (Milano, Bompiani, 2014). Cito alcuni brani dalla Postfazione di questo libro: «Settantamila anni fa l’Homo sapiens era ancora un animale insignificante che si faceva i fatti suoi in un angolo dell’Africa. Nei successivi millenni si trasformò nel signore dell’intero pianeta e nel terrore dell’ecosistema. Oggi è sul punto di diventare un dio, pronto ad acquisire non solo l’eterna giovinezza ma anche le capacità divine di creare e di distruggere» (p. 507). Un po’ più avanti leggiamo: «nonostante le cose sorprendenti che gli umani sono capaci di fare, restiamo incerti sui nostri obiettivi». Il libro infine si conclude in questo modo: «può esserci qualcosa di più pericoloso di una massa di dèi insoddisfatti e irresponsabili che non sanno neppure ciò che vogliono?» (p. 508).
Siamo ancora in tempo per saltar fuori da questa corrente impetuosa, per arrestare questa sorta di tsunami da noi stessi provocato, per convincere anche gli altri che “diventare dèi†non è la strada giusta? Tanto tempo fa, gli autori anonimi della Genesi fecero pronunciare alla loro divinità le seguenti parole: «Ecco che l’uomo è diventato come uno di noi, conoscendo il bene e il male! Ed ora ch’egli non stenda la sua mano e non prenda anche l’albero della vita, sì che ne mangi e viva in eterno» (3, 22). Con l’accoppiata in successione storica di cristianesimo e modernità è proprio questo che si è cercato di fare: mettere le mani sull’albero della vita, sconfiggere teologicamente la morte (San Paolo; Apocalisse), e grazie alla tecnologia e alla scienza della modernità non solo dominare la natura, ma diventare noi stessi creatori di nuove forme di vita e di intelligenza. È l’idea di “uomo nuovoâ€, che, pur con le sue trasformazioni, fa da collegamento tra cristianesimo e modernità , e sui cui “furori antropo-poietici†ho scritto un capitolo del mio libro Fare umanità (Roma-Bari, Laterza, 2013). Nella sua recente enciclica, papa Francesco mette giustamente in guardia l’umanità dall’idea di considerarsi dèi, dominatori del mondo e della natura. «Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data» e, come si legge nella Bibbia ebraica, «“del Signore è la terra†(Sal 24,1), a Lui appartiene “la terra e quanto essa contiene†(Dt 10,14)» (Laudato si’, Edizioni Piemme, pp. 98-99). Ma è difficile non pensare che le radici della modernità affondino nell’idea di un “uomo nuovoâ€, il cui progetto antropo-poietico è segnato dalla volontà di essere sempre più simile a dio. Il mito del progresso infinito, tipico della modernità , è la traduzione, nella storia secolare, della deificatio (“farsi dèi†o “farsi Dioâ€) che animava il Cristianesimo delle origini.
Quali sono, secondo lei, i passaggi indispensabili affinché le società occidentali contemporanee possano riprendere il loro cammino di soggettivazione collettiva evitando la gabbia dello scontro identitario e le forme di dominio oggi espresse dall’imperialismo militare e mercantile?Finora abbiamo parlato di due “gabbie†ideologiche: quella del pensiero identitario, che contrappone Noi agli Altri, e quella della deificatio moderna, che giustifica ed esalta il dominio di Noi sulla natura. Se si giudicano queste ideologie come matrici sia di conflitti insanabili tra gli esseri umani, sia di esiti letali per la stessa umanità , è opportuno chiedersi come si possa uscirne, quali siano i “passaggi†che ci potrebbero condurre verso altri modi di pensare e di agire. Una premessa è ovviamente necessaria: non è per niente facile uscire dalle gabbie mentali, allorché le loro strutture, le loro impostazioni, i loro presupposti, le loro idee, il loro linguaggio sono diventati “nostriâ€, parte di noi, del nostro stesso modo di vedere le cose. Noi infatti siamo le nostre gabbie. Non del tutto, però. Nelle gabbie si vive sempre con disagio e, per fortuna, esistono vie di uscite, ovvero passaggi verso modi alternativi di concepire il mondo. Queste vie di fuga si cominciano a intravedere, allorché si avvertono scricchiolii, si aprono falle, soprattutto quando si determinano traumi, che obbligano a riflettere sui presupposti del nostro agire. I passaggi verso concezioni alternative divengono poi più chiari, quando si guarda con interesse ad altre società , ad altre forme di umanità . Nel mio libro Noi, primitivi del 1990 (Torino, Bollati Boringhieri; seconda edizione accresciuta 2009) ho cercato di dimostrare come l’antropologia – intesa come “giro lungo†– abbia esattamente lo scopo di condurci mentalmente presso altre culture, non importa quanto lontane nel tempo e nello spazio, al fine di cogliere, ed eventualmente apprezzare, modi diversi di organizzare la vita e di affrontare i compiti antropo-poietici che competono agli esseri umani. Se devo però sintetizzare in una parola le modalità di uscita dalle due gabbie indicate prima – ossia il pensiero identitario e la deificatio moderna – mi sentirei di dire che questa parola è “somiglianzaâ€. La gabbia identitaria crea l’Alterità , e così facendo nega o rende del tutto superficiali e superflue, le somiglianze tra noi e gli altri. Allo stesso modo, la gabbia della deificatio crea uno iato tra noi e la natura, resa oggetto di mera predazione e sfruttamento. Per uscire da queste gabbie occorre ripristinare, in maniera convinta, meditata, approfondita, i legami di somiglianza sia tra noi e gli altri, sia tra noi e la natura. Di solito, si sottovalutano le relazioni di somiglianza. Se invece si riflettesse sul fatto che la struttura della somiglianza è data dalla partecipazione, ovvero dalla condivisione (A e B sono simili, se e solo se condividono qualcosa), apparirebbe chiaro che, al posto delle barriere identitarie, contro gli altri e contro la natura, ci converrebbe costruire ponti, vie di comunicazione e di scambio, soluzioni di convivenza.
Qual è la sua opinione sul dramma dei migranti e sulle reazioni, spesso scomposte o apertamente razziste, esibite da alcune frange politiche e dalle fasce di popolazione che esse influenzano/rappresentano? Quali strategie diplomatiche si dovrebbero approntare per affrontare l’emergenza e, al contempo, andare alle radici del problema?I migranti sono esattamente coloro che praticano, sotto i nostri occhi, le vie di fughe più impervie e pericolose, e non certo per più o meno lievi disagi esistenziali, ma per i traumi – bellici, economici, sociali – che devastano i loro Noi e che rendono a loro impossibile la costruzione di una qualche forma di umanità accettabile, per non dire appagante, serena, equilibrata. E noi come reagiamo? Fondamentalmente, come se il loro dramma non fosse anche il nostro. Alla radice, ciò che caratterizza le nostre reazioni è l’assenza del senso di somiglianza, quindi di condivisione, di partecipazione. Al contrario, esiste un profondo senso di estraneità , che divide “noi†da questi “altriâ€: provengono da altri continenti, da altri paesi, da altre culture; tra noi ci sono persino coloro i quali pensano che sono di altre razze. Non vorrei essere frainteso: non è sufficiente introdurre la nozione di “somiglianza†per pensare di risolvere i problemi di questa emergenza. Anzi, in un certo senso è con l’identità – la difesa della nostra identità – che i problemi appaiono più abbordabili, le soluzioni più nette, le regole (di cui tanto si parla) inequivocabili: è per questo motivo che coloro i quali brandiscono i vessilli identitari hanno una così facile e immediata presa sui nostri concittadini.
Vorrei portare un esempio di soluzione appunto “facile e immediataâ€, un caso che in apparenza non c’entra nulla con la questione dell’identità e dei migranti, e che però è, ai miei occhi, emblematico. In un condominio alla periferia di Roma, una donna anziana muore da sola nella sua casa. Passano i mesi, passano gli anni (quasi due). Il cadavere manda un olezzo nauseabondo, che si sente anche all’esterno. I vicini cosa fanno? Sigillano la porta sul pianerottolo con il nastro adesivo da imballaggio «per non “sentirla†più, per proteggere […] la propria indifferenza». Francesco Merlo ha scritto su questo caso un commento impressionante. Persino i due medici che hanno lo studio al primo piano e che scrivevano le ricette per questa donna da tutti considerata “strana†e “svitataâ€, in due anni non si erano peritati di chiedersi dove mai fosse sparita la loro paziente. «Come fanno due medici a non cercare una spiegazione a quella terribile puzza di morte?» (la Repubblica, venerdì 18 settembre 2015, p. 25). Proprio perché i migranti non c’entrano per niente, il caso diventa ancor più significativo, in quanto indice di una mentalità , di un modo di vivere generale: la soluzione facile e immediata è tappare, chiudere, isolare, circoscrivere il più possibile, così da girare la testa da un’altra parte e continuare a pensare alle proprie faccende.
Ma ovviamente questa non è una soluzione adeguata. Né del resto è sufficiente – come ho detto prima – introdurre la nozione di “somiglianzaâ€, la quale è comunque il primo passo, il “passaggio†per cominciare a mettere a fuoco i vari aspetti del problema, per comporre una qualche “cultura†delle migrazioni. Tanto per cominciare, che ne sappiamo dei luoghi da cui i migranti provengono, dei drammi che sconvolgono o tormentano i loro paesi, dei fattori che li rendono tanto invivibili? È molto probabile che il nostro sguardo cambierebbe, se capissimo di più ciò che avviene in quelle regioni dell’Africa e del Medio Oriente, anche perché ci renderemmo conto che noi, con la nostra storia e con la nostra economia, non siamo affatto estranei alle cause, prossime o remote, di quelle tragedie. Ciò che colpisce è l’enorme povertà culturale con cui non affrontiamo il problema, fino a che esso si presenta con urgenza ai confini dei nostri Stati, delle nostre regioni, sulla soglia delle nostre case. E questa ristrettezza di orizzonte si coglie considerando non soltanto la nostra ignoranza circa le cause del fenomeno, ma anche – e forse soprattutto – osservando la nostra pressoché totale sprovvedutezza in rapporto al futuro. È l’attenzione per il futuro ciò che determina la vitalità di una cultura. Nel caso che stiamo prendendo in esame, se non vogliamo limitarci a una semplice e burocratica gestione del presente – per esempio, con la distinzione tra rifugiati aventi diritto e immigrati da rispedire ai loro paesi –, il futuro ha soltanto un nome, un tema, un problema: convivenza. Occorre studiare e approntare tecniche di convivenza: mezzi, espedienti, idee che producano modi accettabili di “convivere†(non semplicemente “coesistereâ€). Altre società – nel loro piccolo, verrebbe da dire, e con i loro limitati mezzi economici – hanno inventato modelli di convivenza, a cui forse, se non fossimo tanto boriosi e arroganti, potremmo guardare con interesse e anche con profitto. Con un’avvertenza conclusiva: in un mondo così interconnesso com’è ormai il nostro, non è pensabile una reale convivenza tra le società umane, se insieme non si decide in primo luogo di convivere con la natura, rispettando le sue risorse e anche i suoi diritti. Papa Francesco, nella sua enciclica, ha colto molto bene questo nesso. È giunto quindi il momento che intellettuali, uomini di scienza, responsabili della comunicazione (giornalisti, opinionisti) e soprattutto politici affrontino la questione in maniera più consapevole e approfondita. Anziché ricominciare a erigere muri (come avviene in questi giorni), perché l’Europa – memore delle tragedie che essa stessa ha generato al suo interno e nel mondo, e ora “toccata†dalle tragedie altrui – non tenta di costruirsi come soggetto collettivo, il quale proponga con vigore il tema della convivenza con la natura, quale condizione necessaria e indispensabile per la convivenza tra gli esseri umani?
Nota bio-bibliografica – Francesco Remotti, professore emerito di Antropologia culturale presso l’Università di Torino, ha compiuto ricerche etnografiche ed etno-storiche in Africa e riflessioni teoriche sull’identità e la somiglianza, oltre che sull’antropo-poiesi. Tra le pubblicazioni più significative: Contro l’identità (1996), Contro natura. Una lettera al Papa (2008), Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia (2009), L’ossessione identitaria (2010), Cultura. Dalla complessità all’impoverimento (2011), Fare umanità . I drammi dell’antropo-poiesi (2013).
[url”Torna alla Home page”]http://megachip.globalist.it/[/url]