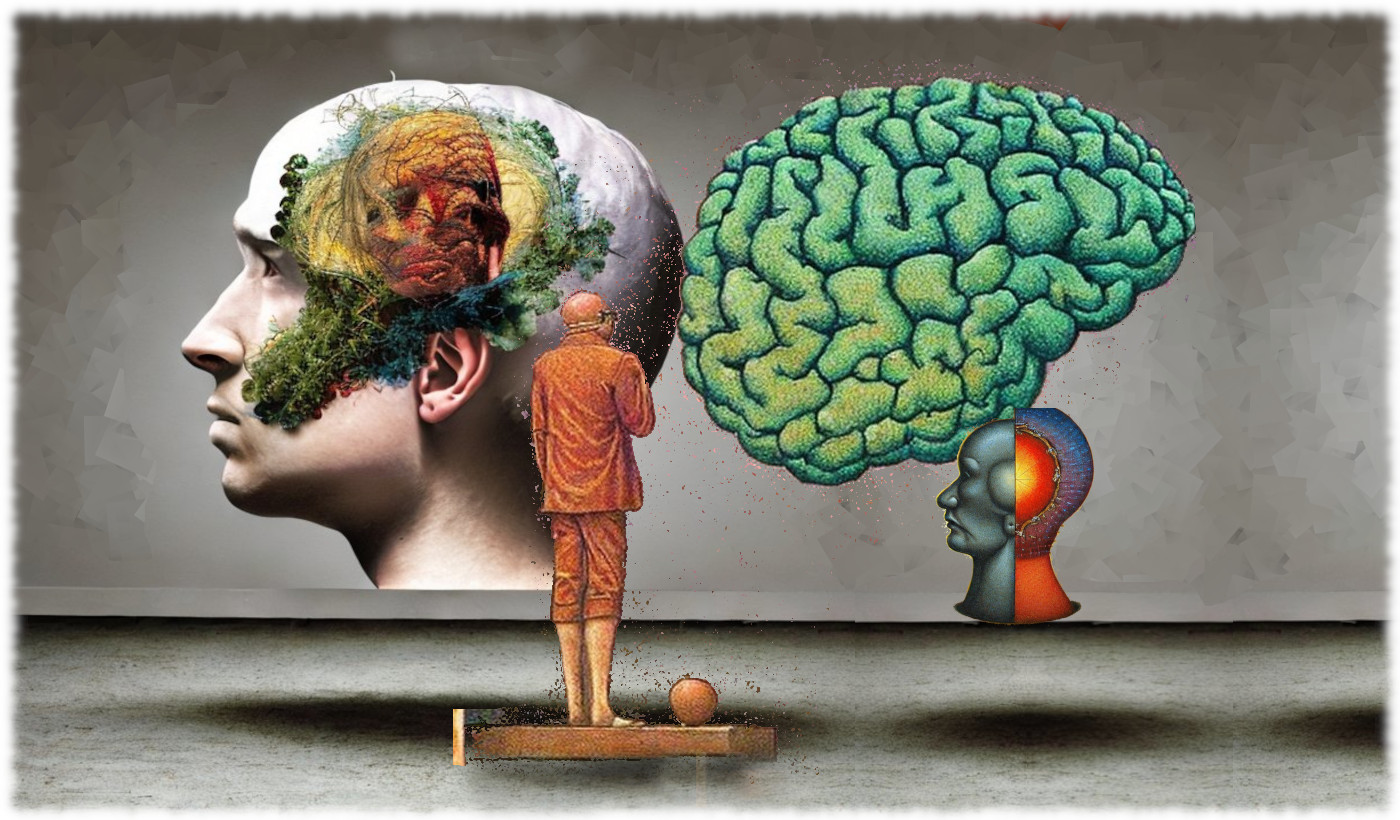di Paolo Bartolini.
Chiunque viva con disagio la deriva antropologica e sociale a cui il tecno-capitalismo ci condanna, sa bene che le forze in campo per una democrazia insorgente sono frammentate, spesso in contrasto tra loro, vittime di un misto epocale di impotenza e agitazione frenetica. Una finta sinistra immemore dei suoi valori fondativi, e una destra neoliberale onnipervasiva, hanno stabilizzato, da almeno quarant’anni a questa parte, un gioco di specchi tossico che sfocia – come avrebbe detto Domenico Losurdo – in un sostanziale monopartitismo competitivo. “Privatizzare i profitti, socializzare le perdite” è il diktat che rimane al centro delle azioni delle élite contemporanee, quelle neocon e quelle che sul versante dei diritti civili e del costume si autodefiniscono progressiste.
Anche la gestione confusa e autoritaria della sindemia Covid-19 testimonia il fatto che il pilota automatico neoliberale, nella fantasia dei ceti dominanti, non può essere disinnescato per quanto riguarda le sue coordinate essenziali. Il mondo multipolare è già tra noi e il declino del blocco angloamericano impatta con questa transizione gigantesca, nella vana speranza di poter arrestare un riequilibrio tra le potenze mondiali. Da qui la violenza del nostro tempo, dove – voglio essere chiaro – non ci sono “buoni” e “cattivi”, ma diversi modi di esercitare il dominio, più o meno “liberal” eppure omogenei per quanto riguarda il loro scopo ultimo: conservare, a favore di pochi, gerarchie e asimmetrie funzionali al sequestro del valore prodotto dalla collettività. Le logiche di potenza della geopolitica sono il problema, insieme alle concentrazioni di denaro che riguardano multinazionali, mass media, centri finanziari e così via. La gestazione di un mondo nuovo è turbolenta, minacciata da numerosi interessi contrapposti. Sicuro è il fatto che, nel campo dei critici verso il sistema, assistiamo alla polverizzazione delle idee, della capacità di fare sinergia, dell’analisi della realtà, della rappresentanza politica e del vivo collegamento con le persone e i territori. Sebbene esistano innumerevoli esempi di attivismo in difesa dei beni comuni, contro la guerra ecc. è indubbio che questa galassia frastagliata di esperimenti si muova talora alla cieca, senza riuscire a collegare i puntini sparsi che attendono di essere raccolti in una figura di senso. Eppure i puntini, una volta uniti, dubito possano restituirci il volto di qualcuno. Questa è la pretesa, ingenua e controproducente, di chi si è smarrito nel bosco buio dei complottismi 2.0. Filosoficamente parlando credo che la figura di verità emergente nel nostro tempo, capace di mettere in stretta comunicazione culture e sensibilità diverse, sia quella della crisi ecologica e dei cambiamenti climatici. Ovviamente questa figura porta con sé la moltitudine di crisi altrettanto esiziali che contraddistinguono il presente: quella delle diseguaglianze sociali, di flussi migratori accelerati, dei colpi di coda del patriarcato, dell’informazione pubblica e di una democrazia minata nei suoi assetti profondi.
Il tecno-capitalismo è insostenibile, e la svolta autoritaria degli ultimi anni mi pare testimoni la necessità, per il potere, di intensificare il suo influsso alternando strategie vecchie e nuove di sorveglianza e controllo. Sul versante dell’immaginario – che rappresenta la chiave di volta per comprendere perché dei gruppi umani subalterni rimangano tali o fatichino ad autonomizzarsi rispetto al discorso dominante – assistiamo a sottili fraintendimenti che spezzano l’intersezionalità auspicabile delle lotte. La consapevolezza che il capitale possa riprodursi solo aumentando i processi di deterritorializzazione, estrazione di plusvalore e fluidificazione delle identità, fa emergere un nuovo nemico che è reale e virtuale insieme: quello del transumanesimo. Ci si sta convincendo, nei territori marginali della critica al globalismo, che esista una sorta di programma condiviso per annichilire i legami territoriali, il senso di identità delle persone, per corrompere le giovani menti introducendo chissà quale teoria gender, per renderci macchine docili e sottomesse all’Algoritmo. Questa paura, e i rispettivi rituali apotropaici che prendono sovente forme reazionarie, antimoderne e antifemministe, mescolano di tutto, presentandosi come sismografi in/consapevoli del caos contemporaneo.
Personalmente penso tutto il peggio del transumanesimo e trovo pericoloso il tentativo di imporre alla vita psichica, sociale e organica il sigillo ipermoderno del “tutto si può fare, quindi si deve fare tutto”. La tecnica e l’accumulazione quantitativa poggiano su queste illusioni nocive, condizionando le nostre esistenze, distruggendo equilibri fragili e delicati (umani ed ecosistemici), drogando il sentire e il volere di miliardi di persone, soprattutto quelle giovani e con meno strumenti intellettuali ed etici per proteggersi. Tuttavia, dinnanzi a questi rivolgimenti profondissimi e ai loro risvolti antropologici, mi preoccupa la tendenza di chi ci invita a perderci nei labirinti senza uscita di un contorto e regressivo “sovranismo identitario”.
La modernità ha prodotto, soprattutto da due secoli a questa parte, identità indifferenti, prese nel gioco acefalo dei mercati e della burocrazia statale: numeri invece che persone. La risposta a questa dispersione/omologazione crescente facilmente imbocca la via reazionaria: “torniamo alle identità forti!”, “viva le piccole patrie!”, “l’uomo è uomo, la donna è donna: condanniamo basta a pretese contronatura!”. Ma siamo sicuri che sia utile alla nostra causa oscillare come pendoli tra gli estremi di questa dinamica? O identità multiple, pasticciate, avvezze a un costante e logorante “personal branding”; o identità rigide, che rivendicano radici e fondamenti forti, fino all’auspicio (si pensi alla ingenua e insieme sconcertante rivalutazione di Ratzinger avvenuta poco tempo fa in funzione anti-Francesco) di restaurare la messa in latino per difendere la Tradizione. Come se fosse possibile opporre alla (dis)cultura accelerazionista, neoliberale e infine transumanista un comparto di certezze e dogmi a buon mercato, che restituiscano a ciascuno il suo posto fisso nel mondo. Questa grottesca alternativa può solo spingerci in un vicolo cieco, come è accaduto – con le distinzioni del caso – nelle recenti diatribe da social Sì-vax/No-vax.
Il problema mi sembra a monte, e richiede uno sforzo di comprensione che solo la filosofia può agevolare. L’identità si costruisce ed è sempre relativa, o meglio “relazionale”. Non sto dicendo, sia chiaro, che la propria identità possa essere scelta e costruita a tavolino con uno sforzo intenzionale. Questa è l’illusione volontaristica del liberismo, che immagina il soggetto come libero agente in libero mercato. Comunque sia, nessuno è mai uguale a se stesso: questa identità non esiste. Come ricorda il filosofo e psicoanalista Miguel Benasayag, l’ipseità di ciascuno, il poterci sentire noi stessi nel corso del divenire inarrestabile del tempo, è determinata – diversamente dagli artefatti digitali e dalle macchine in genere – proprio dal fatto che la vita organica si presenta come una pura dinamica intensiva che unifica il molteplice in situazioni concrete.
Ogni essere umano è quello e non un altro, proprio per il fatto di perdere continuamente delle parti estensive dell’organismo che vengono riprodotte secondo le coerenze interne del corpo in questione. Prendete una vostra foto di quando avevate cinque anni. Vi riconoscerete a stento. Grazie a schemi narrativi e di memoria che si rinnovano, potrete collegare quel viso di allora al vostro di oggi, senza poter negare un fatto eclatante: in voi, nel corso degli anni, sono cambiate quasi tutte le cellule, per non parlare delle emozioni, dei pensieri, delle posture. Siamo e non siamo quella bambina e quel bambino immortalati da una fotografia tanti anni prima. Nessuno, in altre parole, coincide mai con se stesso. Il principio di identità aristotelico
A = A risulta parziale e ingannevole, poiché ciò che ci permette di esistere è il fatto di decoincidere gradualmente da noi stessi. Altrimenti saremmo immobili, pietrificati, morti. Quindi, ricapitolando e facendo un passo avanti: la vita naturale è un processo, con le sue costanti e le sue novità, con i suoi limiti (che il potere vorrebbe cancellare) e con il suo divenire creativo; ad essa, per gli umani, si aggiunge la vita culturale, dunque il sapere riflessivo (nei discorsi e nelle pratiche). La nostra seconda natura culturale ovviamente è intrecciata alla prima in maniera fitta e insolubile, tuttavia fa sì che essere umani significhi vivere una duplicità costitutiva e una distanza peculiare: corpo e parola, vita organica e linguaggio, misura e tendenza alla dismisura. Ecco, allora, che scopriamo qualcosa di interessante: l’identità è un cammino e una relazione. Non esiste un soggetto all’inizio del processo, ma solo come risultante di molteplici fattori concomitanti. Prima di accedere alla lingua madre, quindi alla nostra comunità che ci accoglie e mette in forma come suoi membri (l’antropo-poiesi di cui ha parlato l’antropologo Francesco Remotti), esistono vite individuate anonime. È ricevendo un nome che ci sdoppiamo – detta in modo sbrigativo – tra vita vissuta e vita saputa comunitaria. L’identità, insomma, sboccia come effetto progressivo del nostro essere “l’altro dell’altro”. Del resto la vita umana è rintracciabile solo nello spazio intersoggettivo del riconoscimento: è vita con-gli-altri. Siamo animali ipersociali, che costruiscono la propria identità a partire dagli incontri e dalla cura che altri umani ci dedicano per farci crescere.
Pensiamo alla questione del genere, tante volte evocata in maniera caricaturale, con una superficialità di analisi degna di un Pillon qualsiasi. Mentre la differenza complementare dei sessi biologici è evidente e innegabile, l’identità di genere è qualcosa di più complesso, come anche l’orientamento sessuale e il modo di amare ed essere amati. Ciò non vuol dire affatto che tutto possa essere scelto, come una merce. Tranne alcuni casi, dalle coloriture estremistiche, mi sembra che il movimento LGBTQ+ non rivendichi un rapporto con l’identità di genere e con quella sessuale guidato da incontrollate fregole consumistiche, né abbracci con entusiasmo infantile il mito della destrutturazione perpetua. Queste tendenze, piuttosto, trovano ampio spazio dentro il cerchio dell’immaginario neoliberale e spettacolare, che vorrebbe far intendere che non esistono più vincoli di sorta e che la volontà di ciascuno è sovrana e può direzionare la vita del soggetto dove più le aggrada. Queste trasgressioni a buon mercato sono certamente funzionali alla riproduzione del sistema capitalistico, ma c’entrano ben poco con altre e sacrosante richieste inerenti a diritti e libertà individuali. Il punto, comunque, è quello di non innamorarci della parola e del concetto di “individuo”. Noi siamo condividui e non atomi separati e incomunicanti; il nostro corpoanima è in continua relazione con le situazioni a cui prendiamo parte e che ci configurano sul piano fisico, psichico e spirituale. Nessuno può vivere senza limiti (perché il “campo biologico”, come lo chiama Benasayag, non tollera eccessivi scostamenti dai suoi equilibri) e nessuno è un’identità statica e monolitica “in sé”. Quest’ultima, al contrario, matura solo a partire dal riconoscimento altrui, e poi si modella su regole e credenze condivise. Il vissuto interiore del singolo deve quotidianamente venire a patti con i codici culturali di appartenenza, fino a poterli anche ripensare e trasformare. L’identità, in conclusione, è un’opera, un farsi continuo, che non coincide mai con un “dato definitivo” e nemmeno può ambire a “essere tutto”. Ecco la complessità, che piaccia o meno.
Con questo lungo giro ho potuto solo accennare a temi giganteschi che meritano approfondimento e sforzo di pensiero collettivo. Al cuore di tutto, e anche della politica, dovrebbe essere oggi la comprensione del processo di individuazione che ci rende ciò che stiamo diventando, perché non esistono soggetti belli e pronti, ma tragitti di soggettivazione aperti. Essi danzano, per noi umani, sul bilico di limiti organici insuperabili e di creative possibilità di modificazione della realtà. Questa tensione dell’umano e nell’umano non potrà mai essere risolta definitivamente, bisogna abitarla (ecco la dimensione “etica” del mio ragionamento). Quindi, dinnanzi ai deliri degli ideologi del post-organico, della fluidità assoluta che mima la flessibilità immane del denaro, capace di circolare e investire libidicamente qualsiasi “oggetto”, la risposta non può essere quella di un arretramento a identità altrettanto cosali, maschere di morte prive di soffio perché sottratte al divenire e all’inter-essere (Thich Nhat Hanh) costitutivo dei viventi.
In questi territori impervi della riflessione contemporanea dobbiamo addentrarci senza rigidità, se vogliamo sospendere il giudizio sbrigativo sulle nuove soggettività e, al tempo stesso, mantenere la bussola nella lotta al tecno-capitalismo. Una lotta molecolare, ma anche più strutturata, a seconda delle possibilità reali di incidere sulle attuali dinamiche storiche.
È legittimo aspettarci, da parte di un potere che abbisogna di un controllo crescente sulle masse, l’adozione di strategie di guerra psicologica (come già ammesso da persone bene informate negli ambienti USA e NATO) che inducano le persone a scontrarsi sul nulla, a dividersi secondo linee di faglia plasmate da polarizzazioni sterili, a dare consenso alla falsa alternativa tra élite neoliberali e populisti all’arrembaggio, a rinunciare a ogni diritto per entrare in uno stato di emergenza permanente governato dall’alto.
Se i vettori del conflitto si dispiegano oggi dentro le coordinate che velocemente ho provato a illustrare, credo sia necessario imparare a “diventare” spine nel fianco del potere senza credere di “esserlo” già. Solo riconoscendo che divenire e limiti, innovazione e conservazione, coesistono in una dinamica aperta, possiamo valutare le situazioni e prenderne parte consapevolmente. Mentre i cambiamenti climatici e gli effetti di una crisi ecologica innescata dalla società della crescita a ogni costo, superano ogni frontiera e unificano a forza il pianeta (come fece negli anni Novanta la globalizzazione a stelle e strisce), non possiamo permetterci di rimanere subalterni alla retorica dominante della manipolabilità illimitata del vivente, ma neanche aggrapparci a una critica dell’ipermodernità che sogni improbabili ritorni a fondamenti “assoluti”, a comunitarismi settari o a seducenti quanto fatali nazionalismi.
In definitiva abbiamo bisogno di un pensiero della differenza maturo, che sappia sfuggire al processo uni-formante che l’Apparato tecnico e l’economia di mercato riproducono in ogni loro espressione e al simmetrico e complementare pensiero identitario che si insinua facilmente (insieme a sbandamenti alla QAnon) nell’area di coloro che, autodefinendosi anti-sistema, continuano a pensare se stessi secondo il metro del proprio avversario.
Bibliografia minima
P. Bartolini, Un’ecologia delle pratiche. Curare l’ignoranza dei legami con la filosofia, Mimesis 2023.
M. Benasayag, B. Cany (2021), Corpi viventi. Pensare e agire contro la catastrofe, Feltrinelli 2022.
S. Consigliere, Antropo-logiche. Mondi e modi dell’umano, Colibrì Ed. 2014.
F. Jullien (2017), Il gioco dell’esistenza. De-coincidenza e libertà, Feltrinelli 2019.
C. Sini (2011), Del viver bene, Jaca Book 2021.
Wu Ming 1, La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Alegre 2021.