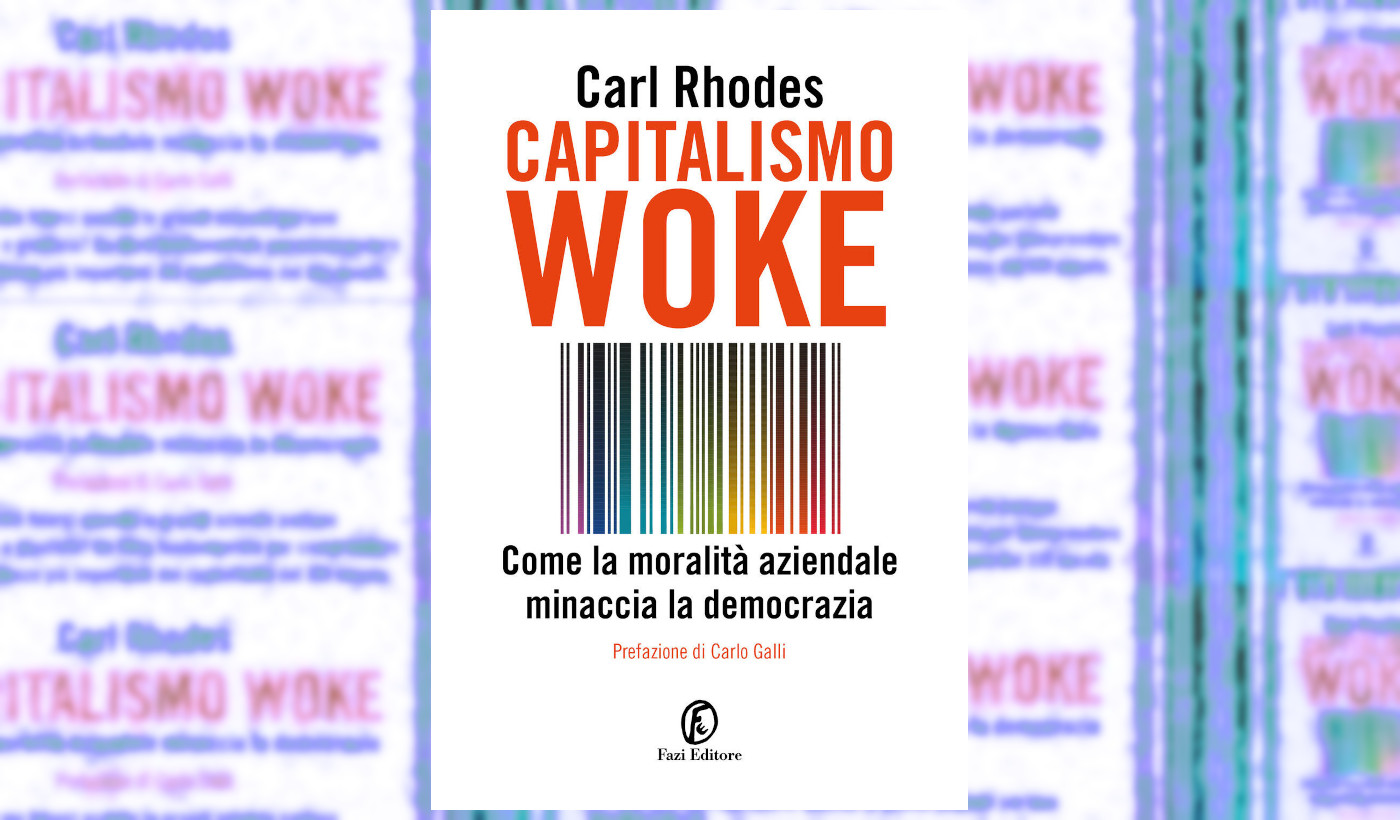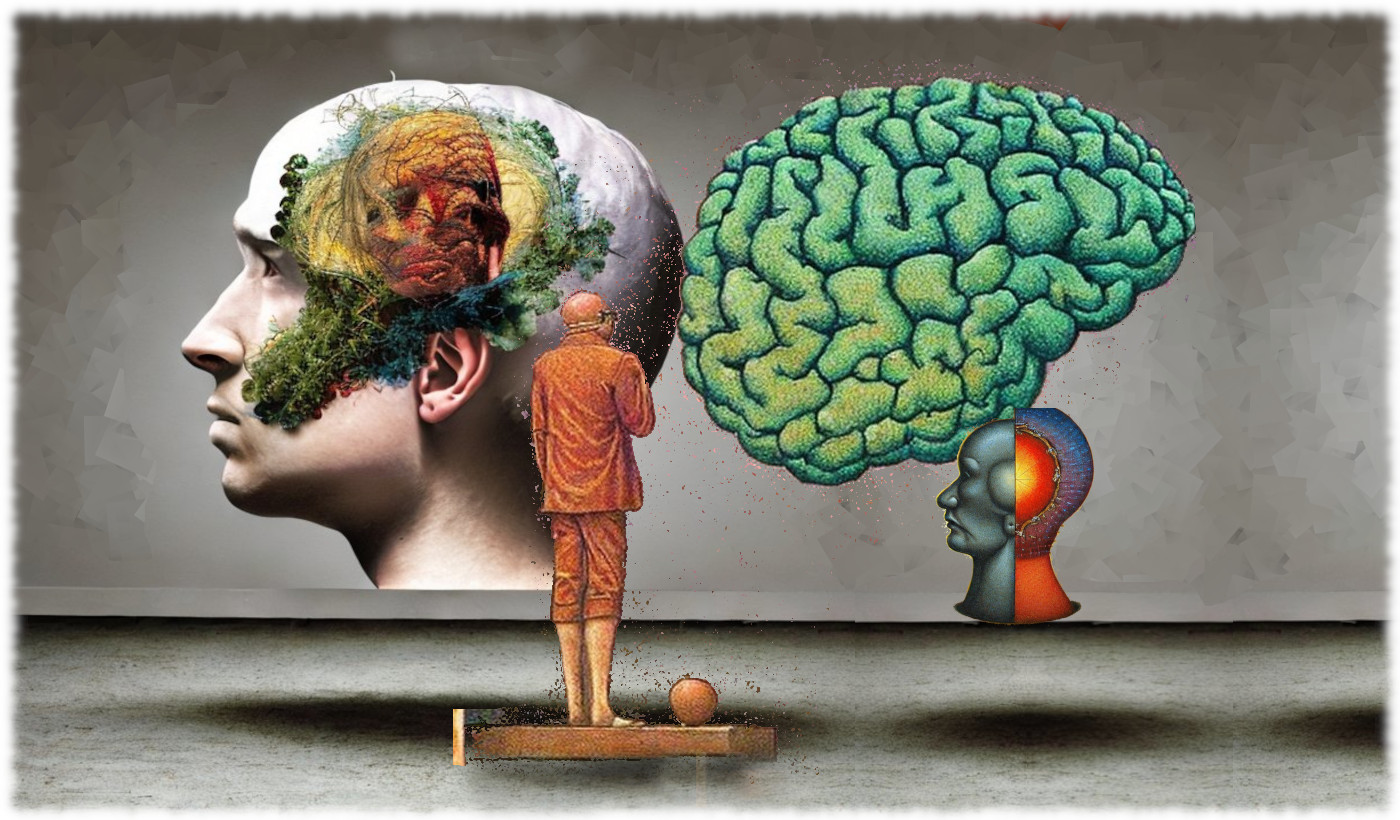francese dell’Internazionale operaia (SFIO) – il partito socialista
dell’epoca – indicava ancora quest’ultima come un «partito della classe
operaia che si prefigge di socializzare i mezzi di produzione e scambio,
ossia di trasformare la società capitalistica in società collettivista o
comunista, attraverso l’organizzazione economica e politica del
proletariato».
Beninteso, nessun partito «socialista» oserebbe oggi dire
una cosa del genere, essendo i socialisti diventati socialdemocratici o
social-liberali.
Che oggi la «sinistra», nella sua quasi totalità , sia
divenuta riformista, che abbia aderito all’economia di mercato, che si
sia progressivamente separata dai lavoratori e dalle classi popolari,
non è certo una rivelazione. Lo spettacolo della vita politica ne è una
ininterrotta dimostrazione.
Per questo, ad esempio, le grida della
sinistra sono così deboli nella grande tormenta finanziaria mondiale
attuale: semplicemente, essa non è disposta più della destra a prendere
le misure che permetterebbero di intraprendere una vera guerra contro
l’influenza planetaria della Forma-Capitale. Come osserva Serge Halimi,
«la sinistra riformista si distingue dai conservatori per il tempo di
una campagna elettorale grazie a un effetto ottico. Poi, quando le è
data l’occasione, si adopera a governare come i suoi avversari, a non
disturbare l’ordine economico, a proteggere l’argenteria della gente del
castello».
La domanda che si pone è: perché? Quali sono le cause di questa
deriva? La si può spiegare unicamente con l’opportunismo dei singoli, ex
rivoluzionari divenuti notabili? Bisogna vedervi una lontana
conseguenza dell’avvento del sistema fordista? Un effetto della
congiuntura storica, cioè del crollo del blocco sovietico che ha
annientato l’idea di una credibile alternativa al sistema di mercato? Ne
Le complexe d’Orphée, il suo ultimo libro pubblicato, Jean-Claude
Michéa dà una risposta più originale e anche più profonda: la sinistra
si è separata dal popolo perché ha aderito molto presto all’ideologia
del progresso, che contraddice nettamente tutti i valori popolari.
Fondamentalmente orientata verso l’avvenire, la filosofia dei Lumi, come
si sa, demonizza le nozioni di «tradizione», «consuetudine»,
«radicamento», vedendovi solo superstizioni superate e ostacoli alla
trionfale marcia in avanti del progresso.
Tendendo all’unificazione del
genere umano e contemporaneamente all’avvento di un universo «liquido»
(Zygmunt Bauman), la teoria del progresso implica il ripudio di ogni
forma di appartenenza «arcaica», ossia anteriore, e la distruzione
sistematica della base organica e simbolica delle solidarietÃ
tradizionali (come fece in Inghilterra il celebre movimento delle
enclosures, che costrinse all’esodo migliaia di contadini privati dei
loro diritti consuetudinari, per convertirli in manodopera proletaria
sradicata e dunque sfruttabile a volontà nelle manifatture e nelle
fabbriche ).
In un’ottica «progressista», ogni giudizio positivo sul
mondo così com’era una volta rientra dunque necessariamente nell’ambito
di un passatismo «nostalgico»: «Tutti coloro i quali – ontologicamente
incapaci di ammettere che i tempi cambiano – manifesteranno, in
qualunque campo, un qualsiasi attaccamento (o una qualsiasi nostalgia)
per ciò che esisteva ancora ieri tradiranno così un inquietante
“conservatorismo†o addirittura, per i più empi tra loro, una natura
irrimediabilmente “reazionariaâ€Â» . Il mondo nuovo deve essere
necessariamente edificato sulle rovine del mondo di prima. Poiché la
liquidazione delle radici forma la base del programma, se ne deduce che
«solo gli sradicati possono accedere alla libertà intellettuale e
politica» (Christopher Lasch).
Questa è la rappresentazione del mondo che, nel XVIII secolo, ha
accompagnato l’ascesa sociale della borghesia e, con essa, la diffusione
dei valori mercantili. Atteggiamento moderno corrispondente a un
universalismo astratto nel quale Friedrich Engels vedeva, a giusta
ragione, il «regno idealizzato della borghesia». (Anche Sorel, a suo
tempo, aveva sottolineato il carattere profondamente borghese
dell’ideologia del progresso).
Ma anche antico comportamento monoteista
che scaglia l’anatema contro le realtà particolari in nome
dell’iconoclastia del concetto, vecchio atteggiamento platonico che
discredita il mondo sensibile in nome delle idee pure. La teoria del
progresso è direttamente associata all’ideologia liberale. Il progetto
liberale nasce, nel XVII secolo, dal desiderio di farla finita con le
guerre civili e di religione, rifiutando al contempo l’assolutismo,
ritenuto incompatibile con la libertà individuale.
Dopo le guerre di
religione, i liberali hanno creduto che si potesse evitare la guerra
civile solo smettendo di appellarsi a valori morali condivisi. Erano
favorevoli a uno Stato che, per quanto riguardava la «vita buona», fosse
neutro. Poiché la società non poteva più essere fondata sulla virtù, il
buon senso o il bene comune, la morale doveva restare un affare privato
(principio di neutralità assiologia). L’idea generale era che si poteva
fondare la società civile solo sull’esclusione di principio di ogni
riferimento a valori comuni – il che equivaleva, in compenso, a
legittimare qualunque desiderio o capriccio che fosse oggetto di una
scelta «privata».
Il progetto liberale, spiega Jean-Claude Michéa, ha prodotto due
cose: «Da un lato, lo Stato di diritto, ufficialmente neutro sul piano
dei valori morali e “ideologiciâ€, e la cui unica funzione è di badare
che la libertà degli uni non nuoccia a quella degli altri (una
Costituzione liberale ha la stessa struttura metafisica del codice della
strada). Dall’altro, il mercato auto-regolatore, che si presume
permetta a ciascuno di accordarsi pacificamente con i suoi simili
sull’unica base dell’interesse ben compreso delle parti interessate» .
Lo Stato di diritto «assiologicamente neutro» è in effetti una doppia
illusione. In primo luogo, la sua neutralità è completamente relativa:
nella vita reale, i liberali affermano i loro principi e i loro valori
con altrettanta forza degli antiliberali. Inoltre, la neutralità in
materia di valori (la teoria secondo la quale lo Stato non deve
pronunciarsi sulla questione della «vita buona», perché ciò lo
indurrebbe a discriminare tra i cittadini) sfocia in pratica in
contraddizioni insolubili, come dimostra la teoria dei diritti
dell’uomo, che proclama diritti contraddittori, dato che alcuni di essi
possono essere applicati solo a condizione di ignorarne o violarne
altri.
Queste contraddizioni sono costantemente sottoposte a procedure
giudiziarie, ma non possono essere risolte in maniera puramente tecnica o
procedurale. La dicotomia destra-sinistra viene spesso fatta risalire
alla Rivoluzione francese, dimenticando in tal modo che essa è davvero
pienamente entrata nel discorso pubblico solo alla fine del XIX secolo.
Alla vigilia della Rivoluzione, lo spartiacque principale non oppone la
«destra» e la «sinistra», ma un’aristocrazia fondiaria dotata di potere
politico e una borghesia mercantile acquisita alle idee liberali.
Nessuno, in quell’epoca, difende veramente il popolo.
Retrospettivamente, il libro di Michéa spiega d’altronde anche
l’ambiguità della Rivoluzione francese: rivoluzione borghese, ma fatta
in nome del «terzo stato» (e soprattutto della «nazione»), ispirata al
contempo alle idee di Rousseau e del liberalismo dei Lumi,
«progressista» con Condorcet, ma affascinata dal’Antichità con
Robespierre o Saint-Just.
Durante tutta la prima parte del XIX secolo, sono appunto i liberali a
formare il cuore della «sinistra» parlamentare dell’epoca (il che
spiega il senso che ha conservato oggi negli Stati Uniti la parola
liberal). I liberali riprendono quell’idea fondamentalmente moderna
consistente nel vedere nello «sradicamento dalla natura e dalla
tradizione il gesto emancipatore per eccellenza e l’unica via d’accesso a
una società “universale†e “cosmopolita» . Benjamin Constant, per
citare solo lui, è il primo a celebrare quella disposizione della
«natura umana» che induce a «immolare il presente all’avvenire».
Mentre
la III Repubblica vede la borghesia assumere a poco a poco l’ereditÃ
della rivoluzione del 1789, il movimento socialista si struttura in
associazioni e partiti. Ricordiamo che la parola «socialismo» appare
solo verso il 1830, in particolare in Pierre Leroux e Robert Owen, nel
momento in cui il capitalismo si afferma come forza dominante.
Il
diritto di sciopero è riconosciuto nel 1864, lo stesso anno della
fondazione della I Internazionale. Orbene, i primi socialisti, la cui
base sociale si trova soprattutto tra gli operai di mestiere, non si
presentano affatto come uomini «di sinistra».
Michéa ricorda, d’altronde, che «il socialismo non era, in origine,
né di sinistra né di destra» e che non sarebbe mai venuto in mente a
Sorel o a Proudhon, a Marx o a Bakunin di definirsi come uomini «di
sinistra». A parte i «radicali», la «sinistra», all’epoca, non designa
niente. In origine, il movimento socialista si pone, in effetti, come
forza indipendente, sia nei confronti della borghesia conservatrice e
dei «reazionari» che dei «repubblicani» e di altre forze di «sinistra».
Ovviamente, si oppone ai privilegi di caste legate alle gerarchie
dell’Ancien Régime – privilegi conservati in altra forma dalla borghesia
liberale – ma si oppone ugualmente all’individualismo dei Lumi,
ereditato dall’economia politica inglese, con la sua apologia dei valori
mercantili, già così ben criticati da Rousseau.
Esso, dunque, non
abbraccia le idee della sinistra «progressista» e comprende bene che i
valori di «progresso» esaltati dalla sinistra sono anche quelli cui si
richiama la borghesia liberale che sfrutta i lavoratori. In realtà ,
lotta, al contempo, contro la destra monarchica e clericale, contro il
capitalismo borghese, sfruttatore del lavoro vivo, e contro la
«sinistra» progressista erede dei Lumi. Si è così in un gioco a tre,
molto differente dallo spartiacque destra-sinistra che si imporrÃ
all’indomani della Prima Guerra mondiale.
È, d’altronde, contro il
riformismo e il parlamentarismo della «sinistra» che il socialismo
proudhoniano o il sindacalismo rivoluzionario soreliano oppongono allora
l’ideale del mutualismo o dell’autonomia dei sindacati e la volontÃ
rivoluzionaria all’opera nell’«azione diretta» – ideale che si
cristallizzerà nel 1906 nella celebre Carta di Amiens della CGT.
I primi
socialisti non erano nemmeno avversari del passato. Più esattamente,
distinguevano molto bene ciò che, nell’Ancien Régime, rientrava
nell’ambito del principio di dominazione gerarchica, da essi rifiutato, e
ciò che dipendeva dal principio «comunitario» (la Gemeinwesen di Marx) e
dai valori tradizionali, morali e culturali che lo sottendevano. «Per i
primi socialisti, era chiaro che una società nella quale gli individui
non avessero avuto più niente altro in comune che la loro attitudine
razionale a concludere accordi interessati non poteva costituire una
comunità degna di questo nome». Proprio per questo, Pierre Leroux, uno
dei primissimi teorici socialisti, affermava non soltanto che «la
società non è il risultato di un contratto», ma che, «lungi dall’essere
indipendente da ogni società e da ogni tradizione, l’uomo trae la sua
vita dalla tradizione e dalla società ».
Per il popolo, il passato non era soltanto ciò che gli permetteva di
inscriversi in una filiazione e in una continuità storiche particolari,
ma ciò che gli permetteva di giudicare il valore delle innovazioni che
gli venivano proposte. Da questo punto di vista, la «tradizione» era più
una protezione che una costrizione. In passato, molte rivolte popolari
avevano già trovato la loro origine in una volontà chiaramente
manifestata di difendere le consuetudini e le tradizioni popolari contro
la Chiesa, la borghesia o i principi.
Il motivo di ciò è che sono le
consuetudini, le tradizioni, le forme particolari della vita locale,
ossia le comunità radicate, a permettere da sempre l’emersione di un
mondo comune e a costituire, ugualmente da sempre, il quadro nel quale
«possono dispiegarsi le strutture elementari della reciprocità e dunque,
ugualmente, le condizioni antropologiche dei differenti processi etici e
politici che permetteranno eventualmente di estenderne il principio
fondamentale ad altri gruppi umani, se non addirittura all’intera
umanità ». Questo sguardo sul passato non contraddiceva affatto
l’internazionalismo o il senso dell’universale.
I primi socialisti erano
perfettamente coscienti che è «sempre a partire da una tradizione
culturale particolare che appare possibile accedere a valori veramente
universali» e che «in pratica, l’universale non può mai essere
costruito sulla rovina dei radicamenti particolari» . Per dirla con lo
scrittore portoghese Miguel Torga, essi pensavano che «l’universale è il
locale, meno le mura». «Dal momento che solo chi è effettivamente
legato alla sua comunità d’origine – alla sua geografia, alla sua
storia, alla sua cultura, ai suoi modi di vivere – è realmente in grado
di comprendere coloro che provano un sentimento paragonabile nei
confronti della propria comunità », scrive ancora Michéa, «possiamo
concluderne che il vero sentimento nazionale (di cui l’amore della
lingua è una componente essenziale) non soltanto non contraddice ma, al
contrario, tende generalmente a favorire quello sviluppo dello spirito
internazionalista che è sempre stato uno dei motori principali del
progetto socialista».
Come il patriottismo non deve essere confuso con il nazionalismo (di
destra»), così l’internazionalismo non deve essere confuso con il
cosmopolitismo (di «sinistra»). Poiché l’abbandono o l’oblio della
propria cultura rendono incapaci di comprendere l’attaccamento degli
altri alla loro, il risultato dell’universalismo astratto non è il regno
del Bene universale, ma la realizzazione di un «universo ipnotico,
glaciale e uniformato» il cui soggetto è quell’essere narcisistico
pre-edipico, immaturo e capriccioso che è il consumatore contemporaneo.
In Francia, l’alleanza storica tra il socialismo (influenzato prima
dalla socialdemocrazia tedesca e poi dal marxismo) e la «sinistra»
progressista si instaura all’epoca dell’affare Dreyfus (1894). Svolta
profondamente negativa. Nato dalla preoccupazione di una «difesa
repubblicana» contro la destra monarchica, clericale o nazionalista, si
delinea un compromesso che partorirà in primo luogo i cosiddetti
«repubblicani progressisti». Si crea allora una confusione tra ciò che è
emancipatore e ciò che è moderno, i due termini essendo a torto
ritenuti sinonimi.
È in questo momento, scrive Michéa, che il movimento socialista è stato
«progressivamente indotto a sostituire alla lotta iniziale dei
lavoratori contro il dominio borghese e capitalista quella che avrebbe
presto opposto – in nome del “progresso†e della “modernità – un “popolo
di sinistra†e un “popolo di destra†(e, in questa nuova ottica, era
evidentemente scontato che un operaio di “sinistra†sarebbe stato sempre
infinitamente più vicino a un banchiere di sinistra o a un dirigente di
sinistra del FMI che a un operaio, a un contadino o a un impiegato che
dava i suoi voti alla destra)» . Questo compromesso ha assunto due
aspetti: «Da un lato, ha portato ad ancorare il liberalismo – motore
principale della filosofia del Lumi – nel campo delle “forze di
progresso†[…] Dall’altro, ha contribuito a rendere in anticipo
illeggibile l’originaria critica socialista, poiché quest’ultima sarebbe
nata appunto da una rivolta contro la disumanitÃ
dell’industrializzazione liberale e l’ingiustizia del suo diritto
astratto». Allora – e soltanto allora – la causa del popolo ha
cominciato a divenire sinonimo di quella di progresso, all’insegna di
una «sinistra» che voleva essere anzitutto il «partito dell’avvenire»
(contro il passato) e l’annunciatrice dei «domani che cantano», ossia
della modernità in marcia. Soltanto allora si è reso necessario, quando
ci si voleva situare «a sinistra», ostentare un «disprezzo di principio
per tutto ciò che aveva ancora il marchio infamante di “ieri†(il mondo
tenebroso del paese d’origine, delle tradizioni, dei “pregiudiziâ€, del
“ripiegamento su se stessi†o degli attaccamenti “irrazionali†a esseri e
luoghi)».
Il movimento socialista, e poi comunista, riprenderà dunque
per proprio conto l’ideale «progressista» del produttivismo ad oltranza,
di quel progetto industriale e iperurbano che ha completato lo
sradicamento delle classi popolari, rendendole ancora più vulnerabili
all’influenza della Forma-Capitale. (Il che spiega anche che
quell’ideale abbia ricevuto una migliore accoglienza tra gli operai giÃ
sradicati che tra i contadini).
D’ora innanzi, per difendere il
socialismo, bisognava credere alla promessa di una marcia in avanti
dell’umanità verso un universo radicalmente nuovo, governato soltanto
dalle leggi universali della ragione. Per essere «di sinistra»,
bisognava classificarsi tra coloro che, per principio, rifiutano di
guardare indietro, così come fu intimato a Orfeo. (Di qui il titolo del
libro di Jean-Claude Michéa: disceso nel regno dei morti con la speranza
di ritrovare Euridice e di riportarla nel mondo dei vivi, Orfeo si vede
proibire da Ade di voltarsi indietro, altrimenti perderà per sempre la
sua bella. Beninteso, egli violerà all’ultimo momento questa
proibizione).
A questa deriva, in cui vede a giusta ragione un’impostura, si oppone
Michéa con una fermezza pari al suo talento. Separato dalle sue radici,
il movimento operaio è stato nello stesso tempo privato delle
condizioni e dei mezzi della sua autonomia. Come aveva ben visto George
Orwell, la religione del progresso priva infatti l’uomo della sua
autonomia nel momento stesso in cui pretende di garantirla emancipandolo
dal passato.
Orbene, sottolinea Michéa, «dal momento in cui un
individuo (o una collettività ) è stato spossessato dei mezzi della sua
autonomia, non può più perseverare nel suo essere se non ricorrendo a
protesi artificiali. Ed è appunto questa vita artificiale (o “alienataâ€)
che il consumo, la moda e lo spettacolo hanno il compito di offrire a
titolo di compensazione illusoria a tutti coloro la cui esistenza è
stata così mutilata». Poiché la sinistra si considera innovatrice, il
capitalismo sarà nello stesso tempo denunciato come «conservatore».
Altra deriva fatale, perché la Forma-Capitale è tutto tranne che
conservatrice! Marx aveva già mostrato bene il carattere intrinsecamente
«progressista» del capitalismo, cui riconosceva il merito di aver
soppresso il feudalesimo e annegato tutti gli antichi valori nelle
«gelide acque del calcolo egoistico». A questo tratto fondante se ne
aggiunge un altro, tipico delle forme moderne di questo stesso
capitalismo. «Una economia di mercato integrale», spiega Michéa, «può
funzionare durevolmente solo se la maggior parte degli individui ha
interiorizzato una cultura della moda, del consumo e della crescita
illimitata, cultura necessariamente fondata sulla perpetua celebrazione
della giovinezza, del capriccio individuale e del godimento immediato
[…] Dunque, è proprio il liberalismo culturale (e non il rigorismo
morale o l’austerità religiosa) a costituire il complemento psicologico e
morale più efficace di un capitalismo di consumo» . Ora, diventando «di
sinistra», il socialismo ha fatto suoi anche i principi del liberalismo
culturale. La sinistra «permissiva» è così divenuta il naturale humus
di espansione della Forma-Capitale. È il capitalismo che permette meglio
di «godere senza ostacoli»!
Per decenni, sotto l’etichetta di
«sinistra», si troveranno dunque associate, in una permanente ambiguità ,
due cose totalmente differenti: da una parte, la giusta protesta morale
della classe operaia contro la borghesia capitalista, e, dall’altra, la
credenza liberale borghese in una teoria del progresso la quale
afferma, in linea di massima, che «prima» non ha potuto che essere
peggiore e che «domani» sarà necessariamente migliore.
In effetti, il
movimento socialista è veramente degenerato dal momento in cui è
divenuto «progressista», ossia a partire dal momento in cui ha aderito
alla teoria (o alla religione) del progresso – cioè alla metafisica
dell’illimitato – che costituisce il cuore della filosofia dei Lumi, e
dunque della filosofia liberale.
Essendo la teoria del progresso intrinsecamente legata al
liberalismo, la «sinistra», diventando «progressista», si condannava a
confluire un giorno o l’altro nel campo liberale. Il verme era nel
frutto. Il liberalismo culturale annunciava già il capovolgimento nel
liberalismo economico. L’ultimo bastione a cedere è stato il partito
comunista, che ha progressivamente smesso di svolgere il ruolo che in
passato ne aveva decretato il successo: fornire «alla classe operaia e
alle altre categorie popolari un linguaggio politico che permettesse
loro di vivere la loro condizione con una certa fierezza e di dare un
senso al mondo che avevano sotto gli occhi».
Ciò che Michéa dice della
sinistra potrebbe, beninteso, essere detto della destra, con una
dimostrazione inversa: la sinistra ha aderito al liberalismo economico
perché era già acquisita all’idea di progresso e al liberalismo
«societale», mentre la destra ha aderito al liberalismo dei costumi
perché ha prima adottato il liberalismo economico. È, infatti,
completamente illusorio credere che si possa essere durevolmente
liberali sul piano politico o «societale» senza finire col diventarlo
anche sul piano economico (come crede la maggioranza delle persone di
sinistra) o che si possa essere durevolmente liberali sul piano
economico senza finire col diventarlo anche sul piano politico o
«societale» (come crede la maggioranza delle persone di destra). In
altri termini, c’è un’unità profonda del liberalismo. Il liberalismo
forma un tutto.
Alla stupidità delle persone di sinistra che ritengono
possibile combattere il capitalismo in nome del «progresso», corrisponde
l’imbecillità delle persone di destra che ritengono possibile difendere
al contempo i «valori tradizionali» e un’economia di mercato che non
smette di distruggerli: «Il liberalismo economico integrale
(ufficialmente difeso dalla destra) reca in sé la rivoluzione permanente
dei costumi (ufficialmente difesa dalla sinistra), proprio come
quest’ultima esige, a sua volta, la liberazione totale del mercato».
Ciò spiega che destra e sinistra confluiscano oggi nell’ideologia dei
diritti dell’uomo, il culto della crescita infinita, la venerazione
dello scambio mercantile e il desiderio sfrenato di profitti. Il che ha
almeno il merito di chiarire le cose. La sinistra si è molto presto
convinta che la globalizzazione del capitale rappresentava una
evoluzione ineluttabile e un avvenire insuperabile, con la politica che,
nello stesso tempo, si adattava alla globalizzazione economica e
finanziaria. Il grande divorzio tra il popolo e la sinistra ne è stata
la conseguenza più clamorosa.
Il Club Jean Moulin aveva aperto la strada negli anni sessanta. La
«seconda sinistra» rocardiana negli anni settanta, la Fondazione
Saint-Simon negli anni ottanta hanno approfondito la breccia attraverso
la quale la sinistra ha cominciato a puntare sulla «società civile»
contro lo Stato e a confluire nel modello del mercato. Nella stessa
epoca, il liberalismo culturale trionfa, il che si traduce in uno
spostamento dei dibattiti politici verso le poste in gioco della societÃ
e verso nuovi gruppi sociali in via di autonomizzazione (donne,
immigrati, omosessuali, ecc.).
Infine, il denaro si impone come
equivalente universale nell’ambito dei valori. «Il vincitore», ha
osservato Jacques Julliard, «fu Alain Minc […] il quale aveva compreso
che, assumendo le idee della seconda sinistra, si poteva fare un
buonissimo deal con il neocapitalismo che si stava imponendo». È emersa
così una sinistra «i cui dogmi sono l’antirazzismo, l’odio dei limiti,
il disprezzo del popolo e l’elogio obbligatorio dello sradicamento». È
così che l’immaginario della «sinistra moderna» – simboleggiata in
Francia da Le Monde, Libération, Les Inrockuptibles e altri insigni
rappresentanti del «circolo della ragione» ideologicamente dominante – è
arrivato a confondersi con quelli dei padroni della BCE e del Fondo
monetario internazionale.
Ed è altresì per questo che «dietro la
convinzione un tempo emancipatrice che non si arresta il progresso, [è
diventato] sempre più difficile ascoltare qualcosa di diverso dall’idea,
attualmente dominante, secondo la quale non si arrestano il capitalismo
e la globalizzazione».
Ormai, la sinistra celebra la crescita, ossia la
produzione di merci all’infinito, negli stessi termini dei liberali. LÃ
dove gli uni parlano di «deterritorializzazione» (alla maniera di
Deleuze-Guattari o di Antonio Negri), gli altri parlano di
«delocalizzazioni».
Per quanto concerne l’immigrazione, esercito di
riserva del capitale, la sinistra «moderna» usa lo stesso linguaggio di
Laurence Parisot («meticciato» e «nomadismo» trasformati in norme).
Influenzata da coloro che hanno «distrutto il socialismo convertendolo
nell’individualismo dei diritti universali e del liberalismo integrale»
(Hervé Juvin), il nemico non è più il capitalismo che sfrutta il lavoro
vivo degli uomini, ma il «reazionario» che ha il torto di rimpiangere il
passato.
«È dunque normale», prosegue Michéa, «che la sinistra “civicaâ€
(quella che ha rotto con ogni sensibilità popolare e socialista) appaia
oggi come il luogo politico privilegiato dove sono elaborate tutte le
trasformazioni giuridiche e di civiltà richieste dal mercato mondiale.
Insomma, essa non è altro che il pesce-pilota del capitalismo senza
frontiere o, se si preferisce, l’avanguardia culturale militante della
destra liberale».
I «valori» della sinistra non sono più valori
socialisti, ma valori «progressisti»: immigrazionismo, apertura o
soppressione delle frontiere, difesa del matrimonio omosessuale,
depenalizzazione di certe droghe, ecc., tutte opzioni con le quali la
classe operaia è in completo disaccordo o di cui si disinteressa
totalmente. Per la sinistra «moderna», che realizza l’alleanza dei
funzionari, delle classi borghesi superiori, degli immigrati e dei
radical chic, «rifiutare l’oscura eredità del passato (che, a priori,
non può non richiamare atteggiamenti di “pentimentoâ€), combattere tutti i
sintomi della febbre “identitaria†(ossia, in altri termini, tutti i
segni di una vita collettiva radicata in una cultura particolare) e
celebrare all’infinito la trasgressione di tutti i limiti morali e
culturali tramandati dalle precedenti generazioni (il regno compiuto
dell’universale liberale-paolino dovendo coincidere, per definizione,
con quello dell’indifferenziazione e dell’illimitatezza assolute) è
tutt’uno».
Non si parla più del capitalismo o della lotta di classe, e
ovviamente di quella anticaglia della rivoluzione. Persino il partito
comunista ha quasi soppresso la parola «socialismo» dal suo vocabolario.
Avendo perduto la sua identità ideologica, non è più in grado di
influenzare la corrente socialdemocratica da cui dipende elettoralmente.
Poiché l’obiettivo non è più lottare contro il capitalismo, ma
combattere tutte le forme di preoccupazione identitaria, regolarmente
descritte come il risorgere di una mentalità reazionaria e arretrata,
«ciò spiega», constata Jean-Claude Michéa, «che il “migrante†sia
progressivamente divenuto la figura redentrice centrale di tutte le
costruzioni ideologiche della nuova sinistra liberale, sostituendo
l’arcaico proletario, sempre sospetto di non essere abbastanza
indifferente alla sua comunità originaria o, a più forte ragione, il
contadino, che il suo legame costitutivo con la terra destinava a
diventare la figura più disprezzata – e più derisa – della cultura
capitalistica» . La sinistra cerca dunque un «popolo di ricambio».
La
fondazione Terra Nova, fondata nel 2008 da persone vicine a Dominique
Strauss-Kahn e presieduta dal socialista Olivier Ferrand, si è resa
celebre pubblicando, nel maggio 2011, un rapporto che suggerisce al
partito socialista di rifondare la sua base elettorale su un’alleanza
tra le classi agiate e le «minoranze» delle periferie, abbandonando
operai e impiegati ai loro «valori di destra» (critica
dell’immigrazione, protezionismo economico e sociale, promozione di
norme forti e di valori morali, lotta contro l’assistenzialismo, ecc.).
Il testo del rapporto è molto chiaro: «Contrariamente all’elettorato
storico della sinistra, coalizzato dalle poste in gioco
socio-economiche, questa Francia di domani è unificata anzitutto dai
suoi valori culturali progressisti». «Tra i due perdenti della
globalizzazione – gli immigrati ghettizzati e i modesti salariati
minacciati – la sinistra in stile Terra Nova sostiene ormai i primi a
scapito dei secondi».
Non è quindi sorprendente che il popolo si distolga da una sinistra
affascinata più dal people e dalla «plebaglia» che dai lavoratori, che
si dichiara per la globalizzazione, sebbene quest’ultima sia anzitutto
quella del capitale, si interessa più alle iniziative «civiche» che alle
trasformazioni strutturali, alla società protettiva del care più che
alla giustizia sociale, alla vita associativa più che alla politica,
allo spettacolo mediatico più che alla sovranità del popolo, al consenso
sociale più che alla lotta di classe – e, come i liberali, concepisce
l’interesse generale solo come semplice somma degli interessi
particolari.
Il popolo non si riconosce più in una sinistra che ha
sostituito l’anticapitalismo con un simulacro di «antifascismo», il
socialismo con l’individualismo radical chic e l’internazionalismo con
il cosmopolitismo o l’«immigrazionismo», prova solo disprezzo per i
valori autenticamente popolari, cade nel ridicolo celebrando al contempo
il «meticciato» e la «diversità » , si sfinisce in pratiche «civiche» e
in lotte «contro tutte le discriminazioni» (con la notevole eccezione,
beninteso, delle discriminazioni di classe) a solo vantaggio delle
banche, del Lumpenproletariat e di tutta una serie di marginali. Non è
sorprendente nemmeno che il popolo, così deluso, si volga frequentemente
verso movimenti descritti con disprezzo come «populisti» (uso
peggiorativo che manifesta un evidente odio di classe). Citiamo ancora
Michéa: «Tra la rappresentazione colpevolizzante della società ormai
imposta dalla sociologia ufficiale (una minoranza di esclusi, relegati
nei “ghetti etniciâ€, sottomessi a tutte le persecuzioni possibili e
accerchiati da una Francia “di villette†che si presume appartenere alle
classi medie) e l’oscura realtà vissuta da queste categorie popolari,
al contempo maggioritarie e dimenticate, la distanza è divenuta
assolutamente surreale.
Il risultato è che le principali vittime degli
aspetti nocivi della globalizzazione non trovano più nel linguaggio
politicamente corretto della sinistra moderna la minima possibilità di
tradurre la loro esperienza vissuta» . «Minando alla base ogni
possibilità di legittimare un qualunque giudizio morale (e, di
conseguenza, rifiutando simultaneamente di comprendere l’uso popolare
delle nozioni di merito e responsabilità individuale), la sinistra
progressista si condanna inesorabilmente a consegnare ai suoi nemici di
destra interi pezzi di quelle classi popolari che, a modo loro, non
domandano altro che di vivere onestamente in una società decente […] In
realtà , è proprio la stessa sinistra ad aver scelto, verso la fine degli
anni settanta, di abbandonare al loro destino le categorie sociali più
modeste e sfruttate, volendo ormai essere “realista†e “modernaâ€, ossia
rinunciando in anticipo a ogni critica radicale del movimento storico
che, da oltre trent’anni, seppellisce l’umanità sotto un “immenso
accumulo di merci†(Marx) e trasforma la natura in deserto di cemento e
acciaio».
Georges Sorel diceva che «il sublime è morto nella borghesia, che è
dunque condannata a non avere più una morale».
Anche Michéa parla di
morale. Ma qui non si tratta del «sublime», bensì della decenza comune
(common decency) tanto spesso celebrata da Orwell. «È morale», diceva
Emile Durkheim, «tutto ciò che è fonte di solidarietà , tutto ciò che
costringe l’uomo a tenere conto dell’altro, a regolare i propri
movimenti su qualcosa di diverso dagli impulsi del proprio egoismo».
«Ciò spiega», aggiunge Michéa, «che la rivolta dei primi socialisti
contro un mondo fondato sul solo calcolo egoistico sia stata così spesso
sostenuta da una esperienza morale» . Si pensi alla «virtù» celebrata
da Jaurès, alla «morale sociale» di cui parlava Benoît Malon. La
«decenza comune», che è mille miglia lontana da ogni forma di ordine
morale o di puritanesimo moralizzatore, è infatti uno dei tratti
principali della «gente normale» ed è nel popolo che la si trova più
comunemente diffusa. Essa implica la generosità , il senso dell’onore, la
solidarietà ed è all’opera nella triplice obbligazione di «dare,
ricevere e restituire» che per Marcel Mauss era il fondamento del dono e
del controdono.
A partire da essa, si è espressa in passato la protesta
contro l’ingiustizia sociale, perché permetteva di percepire
l’immoralità di un mondo fondato esclusivamente sul calcolo interessato e
la trasgressione permanente di tutti i limiti. Ma è altresì essa che,
oggi, protesta con tutta la sua forza contro quella sinistra «moderna»
di cui un Dominique Strass-Kahn è il simbolo e nella quale non si
riconosce più. «Da questo punto di vista», scrive Michéa, «il progetto
socialista (o, se si preferisce l’altro termine utilizzato da Orwell,
quello di una società decente) appare proprio come una continuazione
della morale con altri mezzi».
Come si è capito, Michéa non critica la sinistra da un punto di vista
di destra – e ce ne rallegriamo – bensì in nome dei valori fondanti del
socialismo delle origini e del movimento operaio. Tutta la sua opera si
presenta, d’altronde, come uno sforzo per ritrovare lo spirito di
questo socialismo delle origini e porre le basi del suo rinnovamento nel
mondo di oggi.
Assumendo la difesa della «gente normale», egli rifiuta
anzitutto che si screditino valori di radicamento e strutture organiche
che, in passato, sono stati spesso l’unica protezione di cui disponevano
i più poveri e i più sfruttati. Non è un punto di vista isolato. Il
percorso di Jean-Claude Michéa si inscrive piuttosto in una vasta
galassia, dove troviamo, in primo luogo, ovviamente, il grande George
Orwell, al quale Michéa ha dedicato un libro notevole (Orwell,
anarchiste tory), come pure Christopher Lasch, teorico di un «populismo»
socialista e comunitario, grande avversario dell’ideologia del
progresso , di cui ha contribuito più di chiunque altro a far conoscere
il pensiero in Francia.
Vi troviamo anche, per citare solo pochi nomi,
il giovane Marx critico dei «diritti dell’uomo», i primi socialisti
francesi, William Morris, Charles Péguy e Chesterton, l’Antonio Gramsci
che sottolinea l’importanza delle culture popolari, il Pasolini degli
Scritti corsari (colui che diceva: «Ciò che ci spinge a tornare indietro
è umano e necessario tanto quanto ciò che ci spinge ad andare avanti»),
Clouscard e la sua critica dei liberali-libertari, Jean Baudrillard e
la sua denuncia della «sinistra divina», i films di Ken Loach e di
Guédiguian, la canzoni di Brassens, senza dimenticare Walter Benjamin,
Cornelius Castoriadis, Jaime Semprun, Anselm Jappe, Serge Latouche ,
ecc.
Michéa paragona il liberalismo a un nastro di Möbius, che presenta
una «faccia destra» e una «faccia sinistra», ma senza alcuna soluzione
di continuità . Ciò significa che tra borghesia di destra e borghesia di
sinistra, entrambe eredi della filosofia liberale dei Lumi, ci saranno
sempre più affinità oggettive che tra ciascuna di queste borghesie e gli
antiborghesi del loro campo. E viceversa, che esiste una
complementarità altrettanto naturale tra coloro che difendono il popolo
contro la borghesia sfruttatrice, si situino essi ancora a sinistra o
provengano da destra.
È ciò che constata Michéa quando scrive: «Poco
importa, in verità , sapere da quale tradizione storica ciascuno ha
tratto le particolari ragioni che lo inducono a rispettare i principi
della decenza comune e a indignarsi per la loro permanente violazione ad
opera del sistema capitalistico». In un’epoca in cui la sinistra
intende più che mai raccogliere le «forze di progresso», egli non esita a
ad aggiungere che è «la patetica incapacità di assumere [la] dimensione
conservatrice della critica anticapitalistica a spiegare, in larga
parte, il profondo smarrimento ideologico (per non dire il coma
intellettuale irreversibile) nel quale l’insieme della sinistra moderna è
oggi immersa».
Non avete ancora letto Michéa? Soprattutto, non dite che
un giorno lo leggerete. Leggetelo subito. Immediatamente!
Fonte: Diorama Letterario.