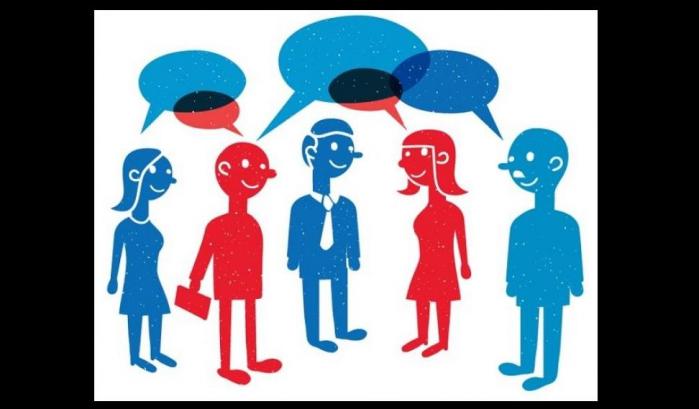di Andrea Zhok.
A partire dalla “crisi subprime” fino all’attuale genocidio palestinese in mondovisione, ciò che colpisce è la manifestazione conclamata del fallimento storico delle liberaldemocrazie.
Prima di addentrarci nel tema è necessario riflettere per un istante intorno a cosa renderebbe, di principio, qualitativamente migliore un regime democratico rispetto ad alternative autocratiche od oligarchiche.
Il vantaggio teorico dei sistemi democratici consiste nella potenziale maggiore elasticità e prontezza nel corrispondere ai bisogni della maggioranza. O, detto altrimenti, un sistema democratico può dirsi comparativamente migliore nella misura in cui consente una comunicazione facilitata tra l’alto e il basso, tra gli individui meno influenti e quelli più influenti, tra chi non detiene il potere e chi lo detiene.
I sistemi autocratici od oligarchici presentano il difetto di rendere l’ascolto dei senza potere una scelta opzionale di chi è al vertice. Non essendoci sistemi di comunicazione efficace dal basso verso l’alto (esistevano cose come le “udienze regali”, ma avevano un ovvio carattere di estemporaneità) bisogna confidare nell’interesse e nella benevolenza dei vertici affinché gli interessi del popolo vengano fatti.
Ora, sarebbe sbagliato pensare che tali situazioni di interesse e benevolenza dall’alto fossero rare nella storia, tuttavia gli elementi di arbitrarietà ed accidentalità erano evidenti, e ad un imperatore, re, o sovrano illuminato poteva succederne uno calloso, ottuso, guerrafondaio ecc.
Il vantaggio comparativo del modello democratico sembra evidente, ma è importante capire che esso verte su UNO E UN SOLO PUNTO, ovvero sulla elevata permeabilità della comunicazione tra alto e basso e del controllo dal basso verso l’alto.
Tolto questo elemento, altri fattori, come la linearità decisionale, possono far pendere la bilancia a favore di governi autocratici, che hanno sempre il vantaggio di poter implementare in maniera facilitata rispetto alle democrazie le decisioni del potere esecutivo (questa è la ragione per cui negli stati di guerra anche i sistemi democratici prevedono l’accentramento del potere in un vertice decisionale).
Tuttavia, la democrazia ideale è la democrazia diretta, che però può funzionare soltanto su ordini di grandezza circoscritti, dove sia la discussione personale che la decisione pubblica possono avvenire direttamente in maniera efficace.
Forse oggi, tramite alcuni supporti tecnologici, si potrebbe estendere ben al di là delle classiche dimensioni dell’Agorà il numero di persone coinvolte in una forma di democrazia diretta, tuttavia è illusorio che si possa fare a meno di un’intermediazione quando i numeri coinvolti sono dell’ordine di milioni. Perciò le democrazie moderne sono democrazie rappresentative.
E qui interviene un noto problema di carattere etico-politico: perché mai un rappresentante eletto dovrebbe fare gli interessi di chi lo ha eletto?
È importante capire che un controllo capillare dal basso dei rappresentanti è tecnicamente impossibile.
L’asimmetria di informazione tra chi gestisce il potere e chi deve sbarcare il lunario è incolmabile.
Per chi gestisce il potere non ci vuole niente a fingere finalità e ragioni del proprio agire diverse da quelle reali (“basta una spolverata di sociale”, diceva recentemente un presunto difensore di istanze popolari).
E anche laddove la dissimulazione alla lunga venga scoperta, comunque le occasioni di rivalsa sono estremamente limitate: dopo 4 o 5 anni ci si può astenersi dal sostenerlo.
Sai che paura.
Questa deriva può essere limitata soltanto dalla temperie morale dell’eletto, dal suo spessore ideale.
Ma qui ci troviamo di fronte ad un colossale problema specificamente legato alle LIBERALdemocrazie.
Il liberalismo, al netto dei significati secondari e magari commendevoli che si possono tirare fuori dal cappello della storia, è essenzialmente un’ideologia che promuove l’egoismo individualista e la competizione di tutti contro tutti.
Lo fa sistematicamente.
Essa è la prima e unica teoria morale che afferma che il perseguimento individuale dei propri interessi, senza se e senza ma, finirà comunque per beneficare tutti (la “mano invisibile” del mercato).
Questa teoria è dimostrabilmente una dannosa idiozia.
In un’atmosfera culturale liberale, che promuove l’egoismo individuale e la competizione illimitata, mentre denigra ogni forma di valore oggettivo, di dovere morale e di fondamento ideale e religioso, non c’è una ragione al mondo per aspettarsi che un rappresentante eletto faccia qualcosa di diverso dai cai propri.
Ovviamente non tutti seguono il canone liberale, ma esso nelle liberaldemocrazie è statisticamente prevalente.
Ciò che ne segue è banale: più perdura la vita di una liberaldemocrazia, più i residui di credenze etiche differenti tendono ad affievolirsi, e più si fa spazio un ceto di rappresentanti autoreferenziali, in vendita al miglior offerente ed essenzialmente in combutta tra loro per preservare le proprie posizioni di potere.
Dunque non c’è nessun mistero nel fatto che continui a funzionare un sistema in cui vengono privatizzati i profitti e addossate al pubblico le perdite (vedi crisi subprime), dove dal referendum greco del 2015 all’odierno Rearm Europe, la volontà popolare conti come il due di picche, dove ci possano essere folle oceaniche che protestano per anni contro il genocidio palestinese mentre i capi di Stato si fanno i selfie con Netanyahu, ecc.
Spesso di queste divergenze di interessi e valori non ci si accorge neppure, perché i cani da riporto della “pubblica informazione” riescono a modellare un’opinione pubblica stanca e distratta (mica tutti hanno il tempo di fare investigazioni private su ogni notizia).
Ma anche quando questa distanza tra gli interessi dei più e le azioni del ceto dirigente appare del tutto conclamata, non cambia nulla.
Oggi trionfa a reti unificate lo spettacolo dell’assoluta impotenza dei popoli liberaldemocratici.
E intanto, nelle forme più spudorate, le “istituzioni” lavorano per mettere a tacere anche quei pochi elementi residui di turbativa, di protesta di piazza, di contestazione sui social.
E i “cani da riporto” col giornale in bocca ti spiegano che mobbing e sputtanamenti avvengono nel nome dell’inclusione; che censure e sanzioni avvengono nel nome dell’informazione; che cariche di manganellatori e idranti hanno luogo per difendere la pubblica incolumità; che provocazioni e corse agli armamenti sono necessarie nel nome della pace; ecc. ecc.
Tratto da: https://t.me/andreazhok/642.