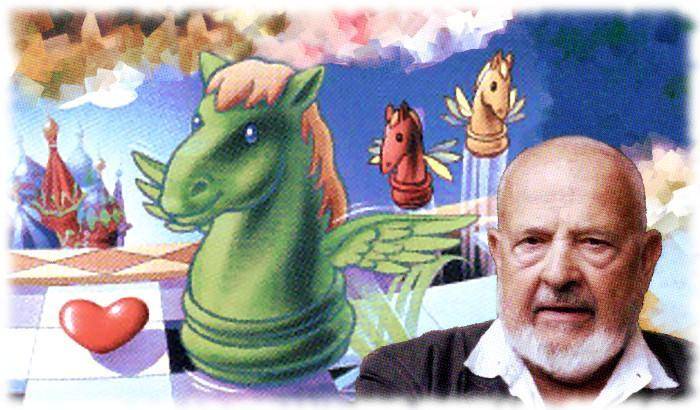Grande anno di celebrazioni, questo 2015: centenario, o cinquantenario, o pluridecennale o comunque anniversario di un sacco di cose. Un tempo si diceva che la «storia per anniversari» era roba per assessori: oggi si comincia forse quasi a rimpiangere quel tempo felice nel quale politici e amministratori avevano talora un occhio per la storia. Il 15 giugno prossimo si celebrerà l’ottavo centenario di un documento dal nome solenne e un po’ ingannatore, Magna Charta Libertatum , attorno al quale aleggia ancora una specie di mito, garante del quale è la grande letteratura dell’Ottocento romantico inglese: quello di sir Walter Scott, del suo Ivanhoe , dell’immaginario «Ritorno del re giusto» rappresentato dal buon re Riccardo «Cuor di Leone» reduce dalla crociata.
Peccato solo che Riccardo I Plantageneto, peraltro coraggioso guerriero, non fosse per nulla un «buon re», sotto alcun punto di vista; e che dalla crociata (la «terza») rientrasse in effetti in Inghilterra nel 1194, ma vi si trattenesse soltanto poco tempo prima di trasferirsi al di qua della Manica, nel suo ducato di Normandia, dove in quanto tale era vassallo del re di Francia Filippo II Augusto, suo compagno d’arme nella crociata e suo avversario storico. Dal continente non sarebbe più tornato: una freccia che lo colse durante una modesta scaramuccia lo fece uscire, appena quarantaduenne, dalla scena della storia.
Che ne è quindi delle vecchie care storie di Walter Scott, quelle che hanno fornito materiale a tanti film da «medioevo in calzamaglia» — da Errol Flynn a Sean Connery — con il brigante-gentiluomo Robin Hood «che ruba ai ricchi per dare ai poveri», in realtà spirito folclorico dei boschi a suo tempo decrittato da Eric Hobsbawm e del quale ha poi finito con l’impadronirsi il solito Walt Disney? Fu l’Inghilterra della regina Vittoria e di re Giorgio V, la Grande patria liberale, imperiale e colonialista della democrazia costituzionale europea, a comporre i differenti episodi della sua storia in un trionfale cammino teso verso la libertà moderna e a stabilire su ciò un longevo mito paradigmatico. All’interno di esso, la Magna Charta rifulgeva di luce propria come documento ed episodio fondatore di un lineare cammino di liberazione scandito dalla [i]Gloriosa rivoluzione[/i] di Guglielmo d’Orange, dalla Costituzione americana, dalla nostra democrazia.
Se accettassimo questa persistente e rassicurante affabulazione parastorica, tutto sarebbe chiaro e coerente. Ma le cose non stanno esattamente così; Max Weber, impartendoci la dura ma salutare lezione del «disincanto», ci ha insegnato a guardar bene dentro il passato per liberarlo da equivoci e contraddizioni. La Magna Charta Libertatum fu un documento promulgato dal re d’Inghilterra Giovanni I detto «il Senzaterra», fratello di Riccardo (erano entrambi figli di Enrico II e della grande Eleonora d’Aquitania), il quale — «graziosamente» e «spontaneamente», sul piano formale — limitava le prerogative regie nei confronti dell’aristocrazia feudale. In realtà si trattò del risultato di un braccio di ferro durato a lungo, di una duplice sconfitta — militare e politica — del sovrano e di un compromesso tra la corona e l’aristocrazia che fondò la vera e propria «monarchia feudale».
La vicenda affonda i suoi presupposti non tanto nella storia inglese, quanto in quella francese. Nel corso dei decenni centrali del XII secolo il re capetingio Luigi VII aveva lavorato al consolidamento del potere della monarchia. La sua opera fu continuata dal figlio Filippo II Augusto (sul trono dal 1180 al 1223), che riformò la cancelleria e la corte e dette ulteriore impulso sia alla riorganizzazione amministrativa della corona, sia al rapporto fra questa e i ceti mercantili, che si sentirono privilegiati e protetti. Era comunque per lui prioritario risolvere il problema costituito dal fatto obiettivo che il re d’Inghilterra, suo vassallo in quanto duca di Normandia, conte d’Anjou e del Maine, duca d’Aquitania e di Guascogna nonché conte del Poitou, era signore effettivo di gran parte del territorio francese: a lui guardavano tutti gli aristocratici che, in un modo o nell’altro, intendevano svolgere una politica autonoma rispetto al loro re.
In Inghilterra, intanto, il regno di Enrico II aveva posto fine a un periodo di torbidi, che tuttavia ripresero alla sua morte (1189): la situazione si andò deteriorando con i suoi figli e successori Riccardo «Cuor di Leone» (1189-99) e Giovanni «Senzaterra» (1199-1216). I due, d’indole entrambi labile e ombrosa e per giunta in discordia tra loro, si erano già ripetutamente ribellati al padre. Giovanni, che aveva prima tentato di usurpare il potere del fratello e gli era poi succeduto nel 1199, condusse una politica scriteriata che gli inimicò al tempo stesso la nobiltà laica e le gerarchie ecclesiastiche: giunse addirittura a confiscare i beni ecclesiastici attirandosi per questo la scomunica di papa Innocenzo III; dopo di che, intimidito dalla reazione, corse ai ripari prestando omaggio feudale al pontefice (il che peraltro rinnovava una consuetudine normanna dell’XI secolo).
Filippo Augusto di Francia colse l’occasione della debolezza e dell’incapacità del suo vassallo Giovanni e, sfruttandone la fragilità , nel 1202 lo dichiarò colpevole di «fellonia» (il delitto del quale si macchiava il vassallo infedele) e lo privò formalmente di tutti i suoi diritti feudali, Aquitania esclusa. La risposta di Giovanni, dopo lunga incertezza, fu l’alleanza con il suo congiunto Ottone IV di Braunschweig, pretendente alla corona reale di Germania e concorrente del candidato favorito del Papa, Federico di Svevia (il futuro Federico II). Si configurò dunque una guerra europea franco-anglo-germanica che vide la coalizione tra Giovanni e Ottone scontrarsi con quella tra Filippo Augusto e Federico. Le sorti si decisero il 27 luglio 1214 nella battaglia di Bouvines, una località franco-settentrionale poco distante da Lille. Fu, quella, la celebre Domenica di Bouvines celebrata in un indimenticabile libro di Georges Duby (Einaudi).
Sconfitto sul campo, Giovanni fu costretto a prestare di nuovo omaggio feudale al re di Francia e a piegarsi ai suoi baroni ch’erano guidati dall’energico Stefano Langton, arcivescovo di Canterbury, riconoscendo tutte quelle prerogative e quei diritti (le libertates) sia della Chiesa, sia della nobiltà feudale laica, che aveva tentato di violare. In particolare dovette rinunziare al diritto d’imporre nuove tasse senza il consenso dei suoi nobili riuniti in un Magnum Consilium (dal 1242 definito Parlamentum) e di consentire che essi, in caso di processo, venissero giudicati da una corte di loro pari.
Va da sé che la Magna Charta non fu evidentemente intesa come uno strumento di «modernizzazione»: al contrario, sotto il profilo giuridico essa rappresentava il ristabilimento di antiche consuetudini poi cadute in disuso. Mentre la corona francese, con la sua forte spinta all’accentramento dei poteri, poneva le basi dello Stato moderno, quella inglese non faceva che piegarsi dinanzi ai diritti tradizionali che la feudalità aveva sempre rivendicato e che essa aveva cercato di strapparle.
Ecco il paradosso che ci sfugge. In sé, il celebrato documento — considerato dal punto di vista «moderno» — fu un «passo indietro» sulla strada che avrebbe condotto allo Stato assoluto e quindi alla democrazia. Esso affermava comunque libertates che poi sarebbero state rivendicate dalle borghesie urbane. Ci sarebbe voluto ancora quasi un mezzo millennio: ma da lì sarebbe scaturita quella libertà britannica, madre dell’americana, nella quale noi riconosciamo una radice della democrazia. Sennonché, si trattava — e si tratta — della democrazia «aristocratico/oligarchica» delle libertà (al plurale), quella di Edmund Burke: non lontanissima sotto molti aspetti dall’ordine auspicato dai tradizionalisti de Maistre e Donoso Cortés, e ben diversa comunque dalla democrazia egalitaria della Liberté , quella di Jean-Jacques Rousseau, madre della Rivoluzione francese, ma anche dei totalitarismi.
(15 febbraio 2015) [url”Link articolo”]http://lettura.corriere.it/il-mito-della-magna-charta/[/url] [url”Torna alla Home page”]http://megachip.globalist.it[/url]